
03 Apr Simone Consorti: l’incoscienza del mare
di Ivana Margarese
Partiamo dal titolo della tua ultima silloge: Voce del verbo mare.
Vivo davanti al mare; prima che crescesse il pino del vicino, potevo vederlo dal terrazzo. Le poesie le scrivo passeggiando sulla spiaggia. A volte rimangono a metà o tornato a casa le ho già scordate: il contrario dell’infinito. Dopo pochi minuti già consegnate all’oblio. Eppure il mare è proprio l’infinità nello spazio, non per nulla è con questo termine che si chiude il più celebre componimento di Leopardi. Voce del verbo mare sta a suggerire il suono incessante del mare ma anche un imperativo categorico, un ordine: quello del Verbo. Poi, se qualcuno vuol vederci un “a-mare” amputato, va bene lo stesso.
C’è un celebre frammento dì Anassimandro che dice: “ da dove infatti gli esseri hanno origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano l’uno all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”.
Il tempo, l’assenza, la ciclicità o la promessa compaiono più volte nella tua poetica anche se coniugati peraltro spesso in modo ironico e non “grave”.
Vorrei che mi dicessi qualcosa in merito.
Come scriveva Paul Ricoeur, mi sembra, il tempo è l’unico tema di cui si occupi veramente a letteratura. I tentativi di trionfare su di esso in Petrarca o nei sonetti di Shakespeare o il tentativo di recupero nel passato da parte di Proust sono solo gli esempi più cristallini ed espliciti. D’altra parte il mare, con le sue onde cadenzate, è ciclico, come le stagioni dell’ anno (la mia preferita è l’autunno) e come certe coazioni a ripetere. E però a me piace giocare rovesciando il tempo tradizionale. Un mio incipit inedito è “Mi son dimenticato del futuro//come se non l’avessi mai vissuto”. Ho scritto poesie sul Capodanno in cui il conto alla rovescia era per tornare al passato: “Anch’io ballerei come loro//bacerei labbra inutili// e mi unirei al coro//Anch’io scolerei lo champagne in un fiato//se stessimo entrando//nell’anno passato”. In un altro testo, mi sono messo perfino ad aspettarlo, il passato: “Il resto del tempo lo passo// ad aspettare l’ora dopo il tramonto// il giorno dopo la domenica//il silenzio dopo la rima/Il resto del tempo lo passo//ad aspettare com’era prima”. In generale, la ripetizione degli atti è qualcosa che mi affascina e mi rassicura. “Habit is a great deadener”, l’abitudine come grande sordina, sosteneva Beckett. La raccolta è basata sull’attesa di qualcosa che non verrà. Continuando a citare Beckett, in Voce del verbo mare una sorta di Vladimiro ed Estragone fusi insieme attendono sapendo che l’attesa è una sorta di preghiera. Ed è normale che Dio non si manifesti dopo una preghiera.
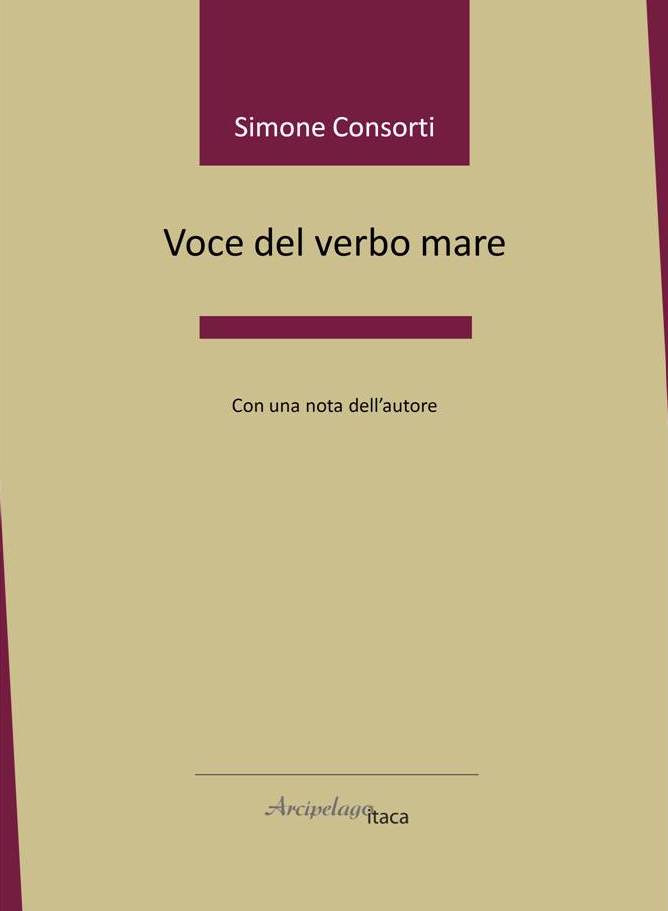
In un bicchier d’acqua affoga Ofelia o Ecco un Amleto ridicolo ridanno vita a personaggi tragici con ironia e con un ritmo più vicino alla frenesia contemporanea. Ritroviamo anche Orfeo, Bernhard, Pessoa, Aldo Moro come protagonisti di alcune poesie. Da cosa nasce questo colloquio?
Sono tutte dramatis personae, e archetipi da declinare in modo nuovo, possibilmente non troppo serioso. Da loro, forse per via delle letture o di certe affinità, a volte mi sento “abitato”, anche se solo per pochi istanti, insomma nascono da un’immagine estemporanea. Per Pessoa l’idea che si desse appuntamento con se stesso, per Bernhard quella della fissità nevrotica degli orari dentro l’ospedale psichiatrico del Berghof. Non è un diventare un altro, quanto ospitare la voce di un altro o farsi ospitare. Chi diventa chi?
Per Les Flaneurs è appena uscito il tuo romanzo breve L’incoscienza, di taglio psicoanalitico, in cui riprendi il topos sveviano del tearapeuta che pubblica lo scritto del suo paziente. Anche in questo caso, scrivendo, ti sei sentito “abitato” dal grande autore triestino?
In realtà, La coscienza di Zeno, dalla cui pubblicazione corrono esattamente cento anni, è stato solo un pre-testo. Per dirla con Montale, una “occasione”. A me premeva parlare del panico, per distanziarlo, letteraturizzarlo, un po’ come Svevo sentì il bisogno di parlare di nevrosi quasi per esorcizzarla. Nel corso della stesura, la fotografia e il teatro, le mie passioni, diventano le strategie dello psicoterapeuta per aiutare il suo paziente. Tuttavia, per parafrasare un celebre adagio, non c’è peggior paziente di chi non è paziente o, meglio, non c’è peggior malato di chi si è affezionato alle proprie tare e preferisce stare male.
Dalla lettura del romanzo salta agli occhi un altro punto in comune con La coscienza di Zeno, ovvero il tono ironico, quasi distaccato.
L’ironia è sempre una distanza. Possiamo ridere solo del passato, a cui siamo sopravvissuti. Pinocchio in carne ed ossa nel finale può ridere della sua versione di legno. Anche il giovane Werher, se fosse divenuto vecchio, avrebbe riso della sua impulsività e di se stesso. Qui i due personaggi sono entrambi miei alter ego ( “la mia metà: il mio doppio” è la frase che ho posto come esergo del romanzo). D’altra parte gli attacchi di panico sono passati da un po’ e anche l’attitudine ad analizzarmi continuamente. Anche le citazioni da Svevo, motivo per cui qualcuno ha definito il mio libro postmodernista mi hanno aiutato a prendere le distanze permettendomi di letteraturizzare la mia esperienza. Diciamo che l’io narrante è, o si illude di essere, lontano dai problemi dell’io narrato.
A chi è consigliato L’incoscienza?
A chi vuole bene al sottoscritto, a chi ne vuole alla casa editrice Les Flaneurs. A chi ama la fotografia e il teatro(non necessariamente in questo ordine). A chi vuole approcciarsi a temi psicanalitici con un taglio più leggero e letterario, a chi ama il quartiere dell’Eur. A chi apprezza i romanzi epistolari. Non a chi vuole fare un paragone a perdere con La coscienza di Zeno, magari per rinfacciarmi che non ho scritto un simile capolavorone. Ho bisogno di lettori ma anche di autostima!

No Comments