
24 Gen Beatrice Zerbini, “D’amore”
di Giorgio Galli
“ami ogni cosa come se
ti riamasse indietro,
ma non è
sempre così
e non hai
mai trovato nelle pagine
un verso, una poesia
che amasse te”
L’amore è fin dal titolo al centro della più recente raccolta di poesie di Beatrice Zerbini, una delle voci più limpide della nuova poesia italiana. D’amore (Interno Poesia, 2022) ha un timbro più doloroso rispetto al precedente In comode rate: con coerenza Beatrice costruisce il canto delle difficoltà dell’amore, della sua bellezza, ma anche di tutti gli ostacoli che lo rendono poco raggiungibile nella quotidianità della vita: dalla difficoltà di darne e riceverne entro la propria famiglia d’origine ai limiti che il mondo esterno oppone al raggiungimento della propria identità:
“Amare non mi è facile
ed è lungo.
Occorre che tua madre
conosca tuo padre,
che tua madre sia nata,
che tuo padre, parimenti nato,
a tempo debito
le sia vicino;
che ti si cresca,
ti si insegni a diventare
chi solamente
tu sai; ecco poi
amare diventa facile
non appena tu sei,
ma bisogna tu sia
e bisogna sia tu.”
La morte è un altro limite, ed è una presenza costante nella raccolta: dal ricordo doloroso di una persona scomparsa alla paura di perdere la creatura amata, dal senso della perdita al bisogno di lasciare traccia di sé dopo la fine, la poetessa esplora quest’ombra che alligna sul quotidiano -ecco un’altra presenza-chiave nella raccolta: il quotidiano-, e pare volere dire che il lutto non è solo quello legato alla morte di un corpo, ma è soprattutto dovuto agli abbandoni che una persona subisce in vita: che è uno stato di privazione affettiva prima che il risultato di un evento biologico. La morte è un’assenza che incombe sullo svolgersi ordinato della vita. Anche Beatrice potrebbe dire, con Camille Claudel, “C’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta l’animo”:
“Ogni volta che ti lascio,
è vedere da lontano
la pace,
rassettare, ripulire,
ricomporre, riordinare
e sentire invece in me
il disordine.”
Altro motivo ricorrente è quello della psicoterapia. La poetessa ne scrive apertamente, ma con ironia, mettendo l’accento -ancora una volta- sulla difficoltà di star bene davvero, di conquistare realmente un equilibrio. La ricerca della serenità è inesausta ma mai pacificata, ed esclude la serenità nel momento stesso in cui ne canta il desiderio. Forse, a uno spirito come il suo, tale raggiungimento è impossibile, ma di sicuro Beatrice mostra di saper maneggiare una complessa materia interiore con l’equilibrio di una scrittura dotata di levità mozartiana e attraverso una sapienza del verso che -diversamente da quanto accadeva nel volume precedente- non si spinge fino al virtuosismo, ma è sempre funzione di un musicalità che conferisce grazia al dire. In ogni passo della raccolta, Beatrice sente il bisogno di stemperare tutto con l’ironia, strumento espressivo e preziosa alleata interiore, che rende la lettura più sorridente e la grevità del vivere più sopportabile. Il che significa che la serenità di Beatrice, ricercata sul piano dell’esistenza, è già palpabile sul piano della forma. E questo è il massimo che si possa chiedere a un poeta.
“Lo prometto, sarò brava,
ma mia aiuti nell’impresa:
voglio essere felice
già dalla sala d’attesa,
sarò rapida e tenace
sono pronta a riparare,
a scavare, ad accettare;
più protesa al risultato:
pensi che ho già elaborato
tutti i traumi e gli accidenti
dei due pazienti
precedenti.”
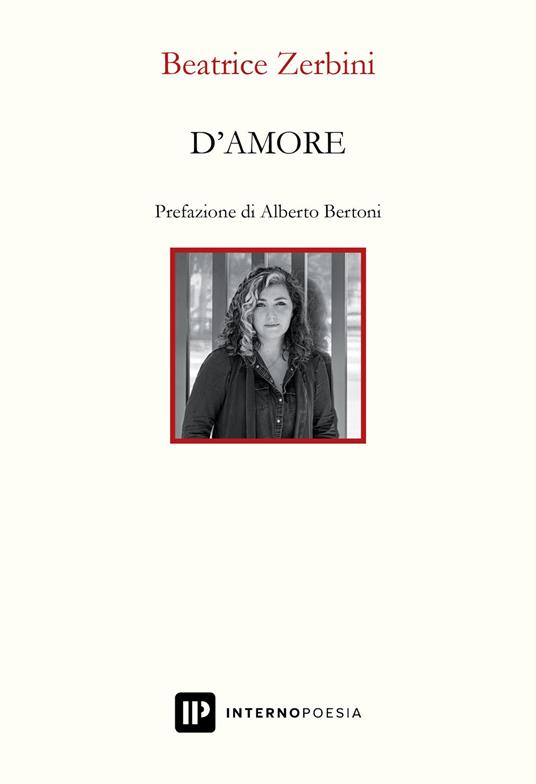

No Comments