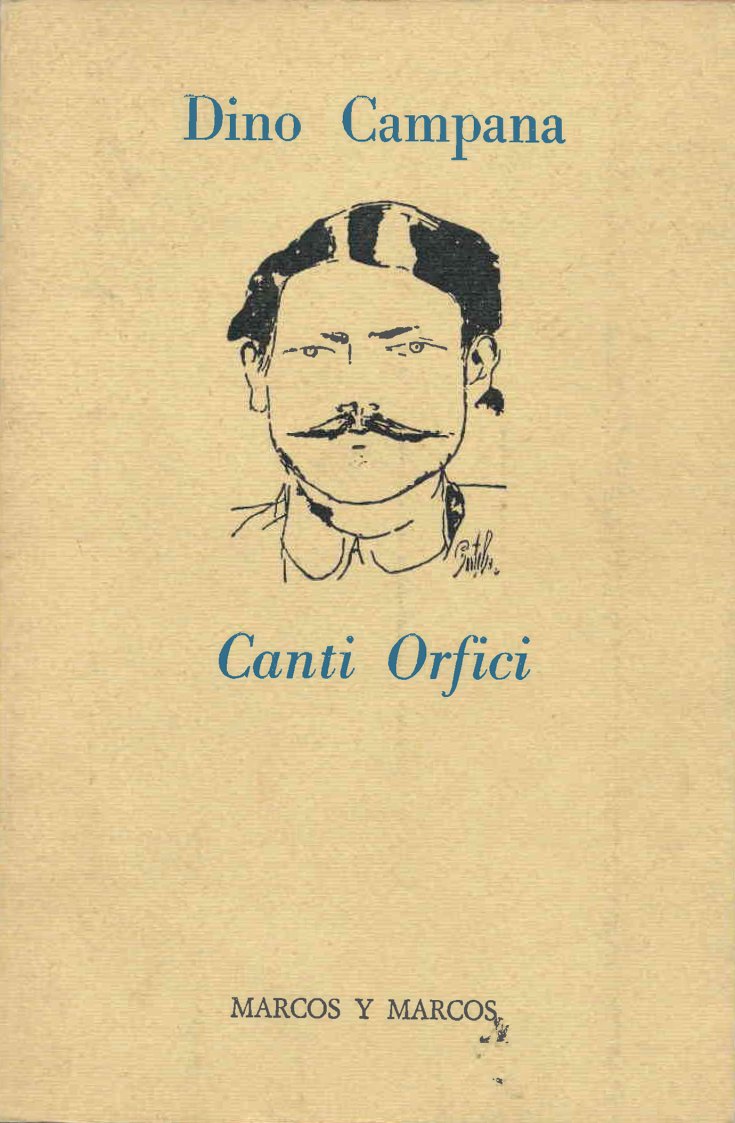
14 Giu L’enigma fatale: Dino Campana e la sua Arianna
L’enigma fatale: Dino Campana e la sua Arianna
di Giovanna Di Marco

Dino Campana, di cui si ricorda spesso la vita in modo romanzato per via della malattia mentale e dell’internamento e della morte in manicomio, è per contro l’autore di un’opera lucidissima e compiuta, i Canti Orfici. Neuro Bonifazi ha fatto però notare che l’aggettivo orfico, riferito a Orfeo, il mitico cantore, non si incontri mai nell’opera, a differenza di altri aggettivi come bacchico, mistico, barbaro, primordiale, proprio perché l’Orfeo di Campana non si accompagna ad Apollo, bensì a Dioniso. Il suo Orfeo, nei fatti, è Dioniso. È chiaro da parte del poeta toscano il richiamo a Nietzsche, levando “le braccia al cielo infinito non deturpato dall’ombra di nessun Dio”.

Altri poeti e artisti del suo tempo incontrarono Nietzsche e in modo fatale, ma qui si vuole esplicitare la vicinanza particolare a un pittore che, negli stessi anni di Campana, aveva ‘inventato’ la pittura Metafisica: Giorgio de Chirico. Già Eugenio Montale aveva messo a confronto le evocazioni delle città italiane in Campana e de Chirico; Maurizio Calvesi ne La Metafisica schiarita fa sua questa intuizione, allargandola con i riferimenti all’infinito, alla solitudine, al mistero e all’enigma, all’occhio veggente e alle piazze italiane che deriverebbero in entrambi da un certo dannunzianesimo. Anche se probabilmente non si incontrarono mai, i loro contatti comuni si possono ricercare nell’ambiente degli intellettuali fiorentini di quel periodo, soprattutto in Papini e Soffici. Nonostante si faccia riferimento a due forme d’arte diverse, i due hanno molte cose in comune: Campana è un poeta tendenzialmente ‘visivo’: “a ogni poesia fare il quadro”, scriveva sui suoi quaderni; de Chirico, un pittore molto letterato.
Inoltre, in un’epoca in cui le Avanguardie crearono delle fratture nella rappresentazione della realtà, loro rimasero profondamente ancorati alla struttura corposa delle immagini, senza mai incorrere in eventuali astrattismi, anticipando, tra l’altro, il cosiddetto Ritorno all’ordine, fenomeno della fine degli anni ’10, inaugurato dalla rivista Valori plastici. Ritornando alla rappresentazioni delle città italiane in Campana e de Chirico, potrebbero essere suddivise in tre gruppi: il primo li accomuna nella stessa, Firenze, luogo dell’arte e del Rinascimento per antonomasia. È la città dell’ispirazione per la nascita della pittura metafisica di de Chirico con l’opera Enigma di un pomeriggio d’autunno (il muro di piazza Santa Croce che collega la chiesa alla cappella ‘de Pazzi, la statua che allude a quella di Dante, a sinistra). Per Campana la città è “giglio e virgulto”, luogo di propagazione della Bellezza della Venere fecondatrice del Botticelli. In entrambi, questa armonia viene volutamente interrotta con richiami inquieti: ne L’Enigma dell’ora, de Chirico stravolge la prospettiva non più ricondotta a un unico punto di fuga; ne La petide promenade du poète, Campana si getta nel disgusto e nello squallore, lontano da quell’armonia agognata. Le ombre di verità più complesse prendono piede in linguaggi che contrastano il primitivo tentativo.

Al secondo gruppo di città, appartengono Faenza, Bologna e Ferrara, le prime due cantate dal poeta, l’ultima dipinta dal pittore: sono le rosse città del mistero, della sensualità. Qui le figure si fanno meno vaghe e più carnali, più persistenti: si pensi al dipinto Le Muse inquietanti; si pensi alle prostitute, a una Eva archetipica incontrata da Campana a Bologna, città rappresentata coloristicamente da una “luce sanguigna”. L’ultimo gruppo è costituito da Genova e Torino, come città del destino: città nicciane; Genova, nella visione finale dell’ultimo componimento dei Canti Orfici diventa immagine di morte (il velario diventa sudario) che è accettazione del destino. Una Genova che crea suggestioni per il passaggio nicciano che “coinvolge Campana in modo brutale”, ci dice Jacobbi; per Torino in de Chirico, Arianna appare per la prima volta nel dipinto La stanchezza dell’infinito. Torino, del resto è Taurinus, città esoterica che ha come emblema il toro, “uno dei quattro animali più enigmatici della creazione”, scrive il pittore, segnato dal passaggio di Nietzsche in quella città. Arianna, raffigurata come statua, è colta nel momento in cui, abbandonata da Teseo sull’isola di Nasso, dopo avere risolto un enigma, quello del Labirinto, si trova nell’attesa di entrare in un altro enigma, quello definitivo: Dioniso. La postura di Arianna ricorda l’iconografia della Melancholia, meditabonda e con la mano che sorregge la testa. Allontanandoci dalle città, pur rimanendone addentro, potremmo rilevare allora che i confronti tra i due artisti non riguardino solo la spazialità e le suggestioni delle piazze d’Italia, ma che il discorso si faccia più profondo relativamente alla rappresentazione della figura umana. Ed è qui che entra in gioco l’Arianna campaniana, finora trascurata. In tutti i Canti Orfici, Campana ricorre al riferimento a una scultura, La Notte di Michelangelo delle Cappelle Medicee a Firenze. La si trova nelle figure femminili che, a mano a mano va incontrando. Come nei riti, le figure diventano mitiche e, come nei miti e nei riti antichi, in questo poeta iniziato al culto dionisiaco, non esiste separazione tra anima e corpo. La verità è qui, senza speranza di trascendenza, ma come volontà di imporsi sul tempo che nasce e muore. E così la figura della Notte ricorre più volte e parecchie donne, statuarie, appaiono trasfigurate e somiglianti alla scultura michelangiolesca.
“Il gomito reggendo la testa, poggiava il gomito reggendo la testa una matrona […] le domande restavano ancora senza risposta”, scrive nel poemetto La Notte. E ancora descrive così una pescatrice in Faenza:
“un viso bruno aquilino di indovina, uguale alla Notte di Michelangiolo”.
Non a caso anch’essa è una figura di donna che con la mano sorregge la testa, come l’Arianna dechirichiana. Non osa, non tenta di chiamarla con il nome della Signora del Labirinto, ma l’universo a cui appartiene questa immagine notturna è il mistero, la sospensione del tempo nell’attesa dell’enigma fatale.

Giorgio de Chirico rappresenterà se stesso nella postura della malinconia, che, oltre a imitare Nietzsche nella sua fotografia più famosa, ripropone lo statuto ontologico della sua anima con l’iscrizione:
Et quid amabo nisi quod aenigma est?[E cosa amerò se non ciò che è enigma?].
Assumendo una posa simile a quella di Arianna, possiamo affermare concordi con Calvesi che Arianna stessa sia un autoritratto del pittore, una figura in cui sdoppiarsi. Straordinariamente, il poeta Campana che si definisce ‘notturno’, appartenente, come la sua amata scultura, al mistero della notte anch’egli per statuto ontologico, si descrive così:
“Oh! Ricordo!: ero giovine, la mano non mai quieta poggiata a sostenere il viso indeciso, gentile di ansia e di stanchezza. Prestavo allora il mio enigma alle sartine levigate e flessuose, consacrate dalla mia ansia del supremo amore, dall’ansia della mia fanciullezza tormentosa assetata. Tutto era mistero per la mia fede, la mia vita era tutta un’ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull’abisso”.
Possiamo parlare anche qui di un autoritratto dell’anima. La statua della Notte è il suo enigma, colto nell’attimo che eternamente nasce e muore. La scultura della Notte è una rappresentazione di sé: è la sua Arianna.

No Comments