
02 Apr Sono stata anch’io bambina. Elena Gianini Belotti. In dialogo con Roberta Ortolano e Samanta Picciaiola
a cura di Ivana Margarese
Roberta Ortolano e Samanta Picciaiola, insegnanti, ripercorrono insieme riflessioni che Elena Gianini Belotti ci ha lasciato in eredità, a un anno dalla sua scomparsa.
In contributi distinti e dialoganti tra loro, sulla scia di Dalla parte delle bambine e Prima della quiete, le autrici fanno proprie e a tratti intime alcune sollecitazioni oggi quanto mai attuali, per aprire il ragionamento sull’educazione alla relazione tra insegnanti e studenti, tra insegnanti e insegnanti, tra presente e passato, in un diario del corpo e delle esperienze che intende il posizionamento politico come un modo di guardare al mondo attraverso una prospettiva intersezionale, necessaria a chi abita la scuola come spazio di un futuro possibile solo nella ricchezza delle differenze.

In apertura al testo scrivete che la vostra riflessione nasce “dalla legittimità di un dire posizionato”. Come dice magistralmente bell hooks il posizionamento è fondamento dell’insegnare: situarsi non solo in uno spazio fisico, ma anche di parola e azione, valorizzando l’incontro tra esperienze diverse e la possibilità di trasformazione che ci è offerta. Vi chiederei di chiarire questa “legittimità“.
Samanta: Ritengo che ci sia un grande lavoro politico e culturale da fare per restituire alla scuola e alla pedagogia la centralità dovuta nel discorso pubblico. Troppo spesso si considera la scuola in astratto e come eterna destinataria di proposte o progetti che vengono paracadutati nelle nostre aule senza avere un’idea chiara di cosa sia il quotidiano scolastico. Questa mancanza di reale attenzione verso il cuore pulsante della scuola nasce da un fraintendimento di fondo: non esistono destinatari a scuola ma persone adulte e persone in formazione che convivono, a volte configgono, decostruiscono o rinforzano tradizioni, saperi e procedure. Questa scuola fatta di corpi e di saperi non sempre riconosciuti e legittimati è lo spazio e il punto di partenza della nostra enunciazione. Io e Roberta condividiamo questo forte radicamento tra i banchi di scuola che è stato il punto di osservazione e di riflessione che abbiamo scelto di mantenere nel nostro lavoro. Certamente debitrici di quell’idea di insegnamento come tensione e desiderio che magistralmente ha illustrato bell books nella sua trilogia. A lei siamo grate e senz’altro questo libro si pone sotto la sua stella.
Roberta: Trovare un posizionamento in classe significa per me accettare profondamente la non neutralità e universalità del sapere e a partire da questo presupposto costruire un dialogo che sia aperto e flessibile, ma anche consapevole della prospettiva dei singoli sguardi che lo compongono, compreso quello dell’insegnante. Per chi è abituata ad adottare un punto di vista transfemminista e politico sul mondo questo è abbastanza scontato, perché si tratta, a partire da sé, di illuminare i rapporti di forza che rendono legittime, appunto, delle posizioni più di altre. Il senso comune però tende a confondere questa legittimità che nasce dal privilegio con una legittimità di “natura”, una neutralità nella quale dovrebbe muoversi soprattutto l’insegnante. Legittimare il posizionamento significa allora restituire prospettiva al corpo, alla mente e alla persona che agisce senza che questo limiti le sue possibilità, la sua responsabilità e la sua capacità di mantenere ascolto e parzialità verso tutte le posizioni e uno sguardo d’insieme solido e sereno.

Di cosa si occupa la collana La biblioteca di Sofia?
Samanta: La collana nasce dal desiderio di valorizzare il fondo omonimo conservato presso la Biblioteca italiana delle donne di Bologna. Un fondo che raccoglie volumi assai differenti destinati a giovani donne, ragazze e bambine.
In collaborazione con l’editore Tab, l’associazione Orlando ha di recente ripreso il progetto di ricerca e diffusione del fondo al quale avevano lavorato nel 1994 Giampaola Tartarini ed Emy Beseghi; progetto che nasce anche grazie all’impulso e alla perspicace intuizione dell’allora direttrice della Biblioteca italiana delle donne, Annamaria Tagliavini, che firma la prefazione al catalogo La biblioteca di Sofia: scrittrici e figure della letteratura per bambine e ragazze di ieri e di oggi.
Quando ho appreso della morte di Elena Gianini Belotti – avvenuta nel dicembre del 2022 – come co-curatrice della collana ho pensato che non poteva mancare all’interno della Biblioteca di Sofia un omaggio a colei che in ambito pedagogico per prima in Italia ha posto il nesso tra desiderio, immaginari e trasformazione sociale. Il senso di questo volume preceduto in collana da un lavoro ugualmente nato dall’esperienza della professione docente – la ristampa in anastatica di Dante parla a bambine di prima e seconda elementare della maestra Antonietta Tinti – sta nel riconoscere come la scuola e l’educazione non solo rappresentino il terreno necessario di un agire transfemminista ma anche e soprattutto come siano luoghi privilegiati di osservazione e d’intervento sul nostro presente in vista di futuri possibili.

Parliamo di bisogni e desideri. In che modo entrano nell’educazione? C’è ancora una differenza tra desideri indotti culturalmente nei bambini e nelle bambine?
Samanta: Penso alla grande eredità di pensiero dei femminismi sul tema del desiderio e credo troppo poco si sia guardato ad essa in termini pedagogici. Tra indotto e spontaneo credo stia un confine molto esile anzi sempre più esile: si consideri ad esempio quanto è immersiva la dimensione online rispetto alle vite dei bambini e delle bambine fin dalla nascita. Sposterei dunque l’attenzione alla consapevolezza, alla coscienza di sé perché mi sembra sia questa la vera assente nei processi educativi odierni.
C’è una grande opacità dei soggetti a se stessi e la scuola, per come la vediamo articolata e agita, non sembra riuscire più a fornire gli strumenti per leggere, dire e significare i propri vissuti e le proprie esperienze. Si tratta di un impoverimento e di un allontanamento dalle fonti dei propri talenti e delle proprie passioni. In una parola dal desiderio. Se a ciò si aggiunge che nel frattempo non è venuta meno la pressione economica e sociale che spinge al binarismo e a una chiara ruolizzazione di genere, credo che il lavoro di una pedagogia transfemminista divenga duplice: oltre a superare condizionamenti e bias di genere e dei generi è necessario recuperare una capacità dialogica intra-soggettiva che alcuni semplificano facendo riferimento all’empatia ma che io propenderei a considerare come un’abilità di relazione con il sé profondo.
Aggiungo un’attenta vigilanza sull’adultismo come forma di de-potenziamento dell’infanzia. Tra il tratto di presunta e mitica innocenza dell’infanzia e la costante inferiorizzazione delle istanze e della lingua parlata da bambini e bambine, noi educatrici assistiamo abbastanza inermi e a volte complici alla cancellazione di aspetti salienti e non addomesticabili dell’infanzia: l’irriverenza, la curiosità, la vicinanza ai linguaggi corporei ed espressivi, la plasticità di vissuti e immaginari e molte altre peculiarità che nel sistema neoliberista in cui siamo immerse vengono invisibilizzati e cancellati a favore della standardizzazione dell’età evolutiva come target di mercato.
In tal modo l’infanzia cessa di esistere e abbiamo un esercito di piccoli adulti e adulte addestrabile al conformismo più prono.
Roberta: Il desiderio e il bisogno giocano in educazione un ruolo decisivo; nella costruzione di una conoscenza che sia efficace e utile per ciascun* al livello individuale e personale è auspicabile e anche molto difficile intercettarli e seguirli, soprattutto in un mondo abituato ad inculcare e non lasciare spazio all’esplorazione, all’osservazione e alla libera espressione di sé.
Da questo punto di vista la scuola assorbe i dettami sociali e culturali che arrivano tanto da un patriarcato arcaico quanto dalla sua versione capitalistica, con il risultato di un appiattimento del gusto delle nuove generazioni verso forme date e comuni. Insegnando nella scuola secondaria superiore spesso mi costa rilevare quanto conservatori risultino gli e le studenti, reduci da un lungo percorso di addomesticamento ormai consolidato. Incentivare una discussione aperta, ricevere le loro opinioni – soprattutto quelle delle ragazze – osservare come queste possano cambiare nel dialogo tra pari, sono attività che si conquistano dopo un lunghissimo periodo di allenamento e scrostamento da pratiche di ascolto passivo che a scuola sanno legittimamente apparire come la norma.
Si tratta del paradosso della libertà, che non sgorga spontaneamente, ma ha bisogno di un’occasione concreta e di un ambiente protetto per esprimersi senza essere rischiosa. Altrimenti tutto ciò che suona come nuovo e trasgressivo causerà una certa incertezza e un qualche sospetto, basti pensare alla preoccupazione ciclica di studenti, genitori e insegnanti al rispetto del fantomatico programma (che come sappiamo non esiste più da tempo) o al legame indissolubile e rassicurante tra la scuola e l’editoria scolastica. L’antidoto dal mio punto di vista sta in quella che bell hooks chiama dislocazione, nello spostamento, nella mescolanza, nella generazione di cortocircuiti che sappiano inserirsi fruttuosamente nella relazione tra la scuola e il mondo. Ritengo importante proporre agli e alle studenti una grande varietà di stimoli, una molteplicità di voci e di prospettive interdisciplinari nelle quali le loro soggettività singole possano provare a rispecchiarsi e a sperimentarsi. Bisognerebbe provare ad abbracciare anche a scuola la via dell’eclettismo e del sincretismo senza temere di sconfinare, perché la strada che conduce alla scoperta del desiderio è tutt’altro che piana.
Da cosa nasce e come si radica a vostro parere l’idea che l’insegnamento debba essere una vocazione o una missione? Samanta nel suo saggio scrive: ” Tanto più eroico e sacrificale resta il mandato tanto meno si apre a ragionare di progettazione condivisa, di coesistenza di stili educativi, di co-costruzione di senso”. Questa sua riflessione mette in luce il prevalere del conservatorismo e della chiusura verso il nuovo che spesso purtroppo abita il nostro sistema scolastico.
Samanta: Credo che la radice del male, per così dire, sia nell’assegnazione dell’insegnamento alla categoria dell’oblativo. Parole come sacrificio, abnegazione, chiamata, vocazione, sono spia di questo permanere nell’ambito della professione-missione.
Non è tanto differente da quanto sostiene i discorsi legati all’assegnazione della cura alla sfera del femminile così come socialmente definito. L’essenzializzazione delle qualità necessarie all’insegnamento segue la stessa logica e da tale gabbia tautologica è difficile uscire anche se le norme e le modalità di reclutamento per l’insegnamento sono quanto di più mutevole si possa osservare sotto il cielo delle procedure selettive professionali. A ciò si aggiunge che dentro il confine della missione non è possibile agire in termini di sperimentazione, valutazione, trasformazione: se una professione è un habitus non si può immaginare di consegnarla a revisione, monitoraggio e cambiamento. Forse per questo all’alternarsi della generazioni di docenti non si registra un reale alternarsi di didattiche e atteggiamenti. Ciò rende la categoria delle insegnanti e dei -pochi – insegnanti una delle categorie più conservative e conservatrici di sempre.
Roberta: L’idea che l’insegnamento sia una missione è strettamente connessa alla femminilizzazione del mestiere, come Gianini Belotti nelle sue opere mostra in prospettiva storica oltre che letteraria.
Sin dai primordi della storia della scuola nel nostro Paese il mestiere è stato associato alle persone socializzate come donne, costituendone anzi uno dei pochi baluardi per la conquista di un’autonomia. Da esse ci si attendeva una presunta naturalezza all’accudimento, e dalle persone socializzate come uomini al contrario un destino di allontanamento dalla cura domestica e dalla dimensione degli affetti. Ancora oggi resta radicato il pensiero che l’insegnante accetti di buon grado le caratteristiche del proprio mestiere, vantaggiose quanto svantaggiose, o addirittura talvolta le potenzi a titolo volontario, perché il suo desiderio sarebbe più forte e più nobile, volto com’è all’interesse delle nuove generazioni, quando non della nazione. Si tratta di un retaggio deprofessionalizzante che solo la parola collettiva e un processo di autocoscienza possono tentare di sradicare.

Nel saggio si legge che “la cultura è confronto e relazione, non un regno di oggetti definiti, codificati dentro una tradizione e presidiati e trasmessi sul filo dell’auctoritas”. Tradizionalmente l’insegnante è stato il depositario autorevole di una cultura codificata da trasmettere. Come cambia il ruolo dell’insegnante nella prospettiva di una cultura intesa come “confronto e relazione”? È la strada per l’oltrecanone?
Samanta: Credo che ciò che cambia sia sostanzialmente il parametro dell’azione educativa: se la cultura si fa e non si trasmette chi insegna non potrà che essere un soggetto in movimento. E questo dovrà avvenire sia sul piano letterale, delle didattiche, con una decostruzione e rivoluzione degli spazi educativi, che sul piano metaforico con l’uccisione, infine, di questo inutile insegnante sovrano nel microregno della classe. Questo è un tratto essenziale di una pedagogia femminista perché ha a che vedere con la revisione profonda del rapporto con il potere. Qui penso alla riflessione di Lea Melandri che ne L’erba voglio analizza con profondità il nesso tra patriarcato e i processi educativi e senz’altro all’acuta analisi di Gianini Belotti stessa che in Dalla parte delle bambine pone i capisaldi della critica all’educazione tradizionale.
Roberta: Se la cultura non è data, ma va ricercata, e soprattutto se la cultura non è una, ma tante, l’insegnante non potrà più essere percepita/o come la fonte della conoscenza, ma come la o il testimone di un processo d’apprendimento, che è individuale e allo stesso tempo collettivo. Dovrà essere responsabile nel fornire strumenti ed occasioni di incontro con il sapere, e monitorarne i passaggi.
Nella relazione con l’altro, che in classe si traduce nel dialogo-dibattito o nel lavoro in piccolo gruppo cooperativo, i punti di vista si smussano, si arricchiscono, prendono strade nuove o si rinsaldano. Non credo che esista una conoscenza che non sia frutto di un incontro. Questo è vero anche per la lettura individuale. L’esperienza può sempre essere influenzata dalla lettura di una recensione o dal punto di vista di un altro lettore e lettrice. In quest’ottica è chiaro che qualsiasi canone, e la sua idea stessa, è destinato ad essere rimesso in discussione, continuamente decostruito, soprattutto quello maschile che, unico e indisturbato, ha dominato per secoli.
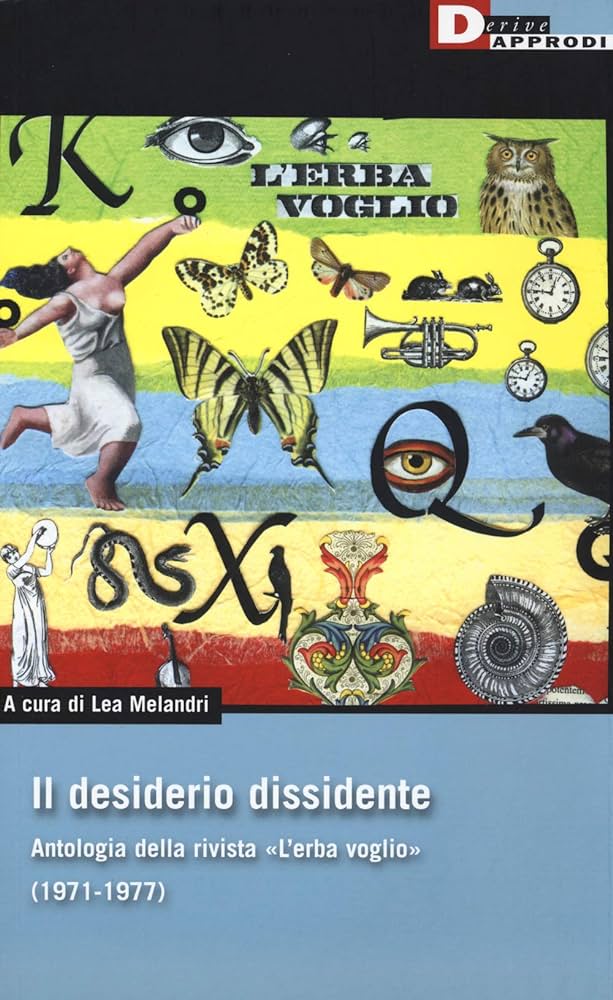
Domande per Roberta Ortolano
Nell’introdurre lo stile di Elena Gianini Belotti a un certo punto citi Machiavelli. Ho apprezzato il riferimento perché si collega a una tradizione di pensiero in Italia di cui stiamo a mio parere sempre più smarrendo la memoria sotto i colpi di facili retoriche o richiami estemporanei.
Grazie per averlo notato. Si tratta di un collegamento un po’ ardito, ma il punto era proprio quello che c’entri tu. In un famoso saggio a commento dell’opera Vita di Galileo Bertolt Brecht sostiene che dopo l’abiura di Galileo il linguaggio della fisica e dell’astronomia non ha vinto contro l’oscurantismo ecclesiastico e reazionario e, anche se quei contenuti si sono poi imposti con il tempo, la mancata rivoluzione di allora ha determinato l’allontanamento di questi studi dal popolo e il prevalere della retorica, del valore della tradizione sul metodo e sulla scoperta.
Si tratta di un ragionamento di grande attualità che vale per tutte le scienze, anche quelle sociali. L’opera di Belotti è profondamente politica, per questo ho pensato a Machiavelli, che seppe liberare il ragionamento politico dall’etica e dalla religione e che fu poi non a caso censurato dalla Controriforma. Ho accostato l’autore a Belotti perché credo che condividano, non certo i contenuti, ma la capacità di disvelare la realtà attraverso l’osservazione sfuggendo dal senso comune. Spesso il passato, anche quello molto lontano, sa insegnarci il progresso, più di quanto non possano il presente e il futuro.

Nel tuo scritto procedi a una decostruzione del materno. Ti domando: Di mamma ce n’è una sola? Inoltre vorrei approfondire con te il tema della “vendetta generazionale”, argomento che andrebbe messo a fuoco nei suoi contorni ambigui e complessi senza rapide rimozioni.
Di mamme ce n’è un intero villaggio anche quando il ruolo di genitore è attribuito ad una sola figura. E nessuna di loro è di per sé innocente. Lo stesso chiaramente si potrebbe dire dei padri. La realtà delle relazioni parentali è complessa, variegata, ampia – sempre – non solo per quelle famiglie che sono dette arcobaleno perché composte da genitori dello stesso sesso. Mi sembra sia tempo che la società se ne accorga e costruisca narrazioni adeguate allo stato di realtà e con esse normative che sappiano rispondere alle esigenze reali delle persone e delle loro relazioni. Non c’è lo spazio qui per entrare nel merito culturale e giuridico, ma è evidente che sulla genitorialità e la cura dei e delle minori c’è ancora molto da fare.
Il tema della “vendetta generazionale” mi affascina negli archetipi mitici (penso alle Erinni, divinità greche della notte che vendicavano i delitti consumati all’interno delle famiglie; o alla strega della favola di Biancaneve che nella prima versione dei fratelli Grimm era la madre della giovane bella), quanto nella sua applicazione nella realtà. Belotti individua secondo me un nodo cardine, valido in qualsiasi forma di oppressione radicata, la cui vittima è inconsapevole: la riproduzione della violenza. Senza voler cadere nello stereotipo che con facilità demonizza la figura femminile (quella è una storia che conosciamo fin troppo bene) credo che questo sia un capitolo non solo attuale, ma ancora non abbastanza esplorato, almeno in questa ultima ondata transfemminista.

“Un contratto pubblico a tempo indeterminato, anche se così sottopagato, garantisce una certa tutela nella malattia, nella maternità, nella pensione. Nella mia storia personale questo aspetto ha avuto un peso: mentirei se non lo ammettessi a me stessa. Ma si tratta di un peso che nasce da quello stesso sostrato culturale che organizza il mondo in maniera tale che le donne conquistino un’indipendenza risicata, fragile, perennemente imperfetta”. Trovo questa riflessione di grande importanza. La sottoscrivo come docente e come donna dvive da sola e lavora ogni giorno in un contesto a cui si rivolge pochissima attenzione, se non in maniera retorica e ipocrita, e che viene sottovalutato anche dal punto di vista di una piena indipendenza economica ( e da questo come si sa dipende anche la nostra possibilità di scegliere).
C’è un collegamento diretto tra la femminilizzazione del mestiere insegnante e il fatto che sia un lavoro così sottopagato, rispetto alle medie europee, soprattutto se consideriamo il livello di selezione cui è sottoposto. Sul cosiddetto reclutamento insegnanti (un termine militare che è un tutto dire…) potremmo soffermarci per giorni. Chiunque insegna sa che di anno in anno le regole cambiano, e a parità di posto le storie che hanno portato a quel conseguimento sono le più disparate. Nessuna però è una strada spianata: concorsi, corsi abilitanti a pagamento, graduatorie, lavoro precario, somma di titoli, spostamenti. E poi chi lo consegue e vive in una grande città non godendo del sostegno economico di un nucleo famigliare allargato, nuovo o di origine, non sarà probabilmente in grado di permettersi di vivere in una casa senza condividerla, per dirne una. Chiaro che il contesto sociale attuale in Italia e nel mondo pone sfide molto più ambiziose di questa, soprattutto per le donne*, e sta di fatto che uno stipendio fisso mensile resta ancora, tristemente, un privilegio, ma credo che la questione non vada oscurata, proprio per quell’equivoco, che dicevamo sopra, per cui quota parte di questo mestiere sia considerato una specie di “destino naturale”.
Quando descrivi il tuo ingresso quasi obbligato (per le ragioni spiegate sopra) nel mondo della scuola, precisi che hai cercato di portare a scuola quel mondo fatto di teatro, libri e cinema che aveva attratto la tua curiosità fuori dalla scuola e prima di diventare insegnante. A parte la considerazione banale che teatro, libri e cinema dovrebbero già essere al centro dell’insegnamento scolastico, mi interessava riflettere su questo approccio “olistico” alla nostra professione: molte coltivano interessi artistici e intellettuali che però restano fuori dalla pratica di insegnamento, come fossero una zona franca di realizzazione, un luogo dove esercitare la propria vera essenza di donne colte e impegnate, mentre la scuola resta un mezzo di sostentamento rispetto al quale ci si sente sottostimate, se non addirittura “sprecate”. Tu scegli di unire i due mondi, dentro e fuori dalla scuola: come si è sviluppata negli anni la contaminazione -immagino reciproca – tra questi due mondi? La vita di fuori riesce ad entrare davvero nella nostra scuola-dispositivo e che impatto ha?
Verissimo, i miei interessi artistici e culturali sono strettamente collegati alle esperienze didattiche e viceversa. Oggi non vivo la scuola con frustrazione, almeno non da questo punto di vista specifico, perché mi dà gioia condividere con ragazze e ragazzi, nei limiti del possibile, libri, spettacoli, film, incontri con autori e autrici e situazioni culturali. Trovo senso in questa continuità che mi vede coinvolta in un processo dinamico e sempre aperto, in cui io stessa faccio delle scoperte insieme ai ragazzi. La didattica è anche un terreno di ricerca, non dovrebbe essere una ripetizione o un’applicazione asettica di ricette e formule, per questo la cultura la accende e spesso da un laboratorio teatrale, da un corso di scrittura, o da un’assemblea transfemminista e perfino da una manifestazione che io frequento possono sorgere idee interessanti da rielaborare e trasformare in aula.
Mi è capitato moltissime volte. Lo scambio con il fuori passa attraverso varie pratiche. Da una parte ci sono io che me ne rendo veicolo. Dall’altra ci sono le iniziative che effettivamente si riescono a mettere in pratica con la scuola, come portare i ragazzi e le ragazze al cinema, al teatro, farli incontrare con artisti e intellettuali, renderli protagonisti di progetti culturali in collaborazione con associazioni, enti, spazi, metterli in rete con studenti di altre scuole. Per come concepisco io la didattica la vita di fuori è sempre coinvolta, anche solo come orizzonte di riferimento, come interlocuzione per la realizzazione di compiti di realtà, come podcast, video, testi, per tenere sempre acceso il dialogo con il mondo, e sempre vivo il più nobile dei compiti della scuola, cioè quello di cambiarlo.

Per Samanta Picciaiola
Vorrei mi parlassi del caso della maestra Italia Donati e delle tue considerazioni nel leggere il romanzo che Elena Gianini Belotti le ha dedicato.
Il caso di Italia Donati fu emblematico nell’Italia post unitaria perché mise in evidenza la condizione di molte giovani donne, provenienti dalle classi sociali meno abbienti, che tentavano la via dell’insegnamento alla scuola elementare affrontando una serie di difficoltà legate alla migrazione interna, alla precarietà del loro mestiere e a profonde tare culturali. Tare che osteggiavano la possibilità per una donna di emanciparsi attraverso una professione. Gianini Belotti si era già accostata al tema della vita delle maestre in un’altra opera intitolata Pimpì Oselì dai toni più amari e dalla profonda ispirazione autobiografica. Non dobbiamo dimenticare che la mamma di Gianini Belotti stessa era un’insegnante di scuola elementare e che aveva dovuto trasferirsi per esercitare la professione, costringendo la piccola Elena e suo fratello a seguirla in una valle chiusa e arretrata del bresciano. Di quell’esperienza l’autrice racconta mettendo in luce le dinamiche di violenza subita all’interno della scuola, sia da bambini e bambine, che dalle docenti stesse. Erano gli anni del Fascismo e le mura scolastiche definivano uno spazio naturale di rinforzo del sistema autoritario pienamente in linea con il regime. Tornando a osservare le vite magistrali nel 2003, Gianini Belotti sceglie con Prima della quiete di realizzare una riscrittura della vicenda di Italia Donati che l’autrice stessa definisce “prima martire del sessismo”. Un certo distacco temporale e forse emotivo rispetto alla materia autobiografica di Pimpì Oselì, le consente di guardare con maggiore indulgenza alla vicenda di Italia spostando lo sguardo sul contesto che poco a poco piega la volontà della giovane maestra fino al suicidio. L’atteggiamento maldicente della comunità del piccolo paesino di Porciano, la matrice violenta del desiderio maschile che il giovane corpo della maestra svela, l’assenza di solidarietà e di trasparenza nelle relazioni lavorative e umane che Italia tenta di intessere, sono i tasselli di un arazzo che Gianini Belotti con eccezionale dote di scrittura ci consegna a testimonianza di una cattiva coscienza nazionale. Il suicidio di Italia Donati fu un fatto che scosse il Paese. Il lavoro di documentazione che Gianini Belotti fece per la costruzione del romanzo fu importante e ben lo testimoniano le molte cartelle di materiale raccolto dalla scrittrice sulla vicenda della maestra di Porciano. Prima della quiete si colloca nella dimensione del romanzo storico con uno sguardo rivolto alle esistenze femminili cancellate come quelle delle tante maestre che con passione e resilienza accudirono i bisogni di alfabetizzazione e di conquista delle abilità di base – leggere, scrivere e far di conto – di un intero Paese. Nella figura di Italia Donati la scrittrice condensa molteplici desideri: quello di restituire giustizia alle donne e al ruolo giocato dentro un nascente sistema d’istruzione nazionale, di disvelare l’oppressione legata ai ruoli di genere e infine la necessità di costruire una coscienza di “classe” legata alla scelta magistrale capace di liberare davvero la professione dalle gabbie del mito svecchiandola e sottraendola all’ipostatizzazione mortifera che l’attanagliava (e in parte ancora oggi l’attanaglia).
Esiste un archetipo della maestra come figura irreprensibile. Come scrivi bene tu, per noi docenti ” il pantaloncino corto, la maglietta scollata, la sigaretta in mano o il bicchiere di birra non passeranno inosservati”. Mi interesserebbe approfondire il tema della censura collettiva e dell’autocensura all’interno della nostra professione.
Come ho provato a spiegare nel libro partendo dalla mia esperienza personale, è praticamente impossibile non avvertire l’incalzare dell’esempio una volta abbracciata la professione magistrale. Nel considerare le dinamiche che sospingono ciascuna di noi, in quanto insegnanti, a identificarsi con un profilo ben definito quasi agiografico scopriamo l’automatismo che ci consegna a un’immagine onnicomprensiva di un femminile domato, condiscendente e prono, cinghia di trasmissione del potere ciseteropatriarcale. Ebbene l’evasione dal mito non è cosa semplice e richiede la decostruzione del mito stesso. Penso si debba partire dalla constatazione che il mito è vivo e vegeto, che il potere pervasivo del sistema di comunicazione non ha corrotto il profilo tramandato della maestra ma ha semmai aumentato le occasioni di controllo e di censura. Mi preoccupa la tendenza a sconfinare dal perimetro scolastico cercando di normare e indirizzare i comportamenti delle insegnanti invocando l’adeguatezza al modello, la necessità dell’exemplum intesa come conferma della norma: all’insegnante si chiede (da contratto) di non essere “divisiva” rispetto alla sua comunità. Diversi ormai i casi di docenti raggiunte da provvedimenti a seguito di condotte relative a contesti extra scolastici come manifestazioni, cortei ed iniziative. E a fare da nefasto antecedente c’è il caso di Mariasilvia Spolato.
Con una metafora molto ben riuscita, quella del gioco della palla avvelenata, evidenzi l’inveterata pratica di separazione dei vari ordini scolastici , nonostante la nascita degli istituti comprensivi, e l’abitudine a denunciare un diminuito livello di preparazione delle classi all’inizio del proprio ciclo di scuola. Mi piacerebbe una tua riflessione in merito.
Credo che sia il vero e profondo rimosso delle politiche scolastiche della storia repubblicana. La persistenze frammentazione dei percorsi e l’incapacità ad articolare in maniera sensata e unitaria il progetto educativo, fa il paio con una rigida divisione in “gradi” che riprende modelli organizzativi di tipo militare. La stessa gerarchia si riflette nella segmentazione dell’insegnamento inteso come carriera. Nel libro ho provato a forzare il discorso attraverso alcuni paradossi per mostrare come ci siamo accomodate dentro l’idea che la professione docente sia una scalata verso il vertice che pone i gradi di scuola inferiori come gavetta o attesa. Al punto che nella vulgata si fatica persino a immaginare che un’insegnante impegnata in accademia possa un giorno trovare necessario o importante abbracciare l’insegnamento nei gradi inferiori. Certamente a questa piramide corrisponde una differenza economica spropositata tra la docenza alle scuole dell’infanzia/primaria e in Università ma questo, a mio avviso, è uno di quei casi dove la struttura poggia saldamente sulla sovrastruttura. Credo che prima venga il discredito sociale che investe maestre di primaria e infanzia rispetto al prestigio accademico e che da lì si articoli un corrispettivo economico conseguente. Se nei gradi inferiori la professione si sporca con la cura mano a mano che si sale la docenza si pulisce di ogni sbavatura di accudimento. E se consideriamo che tutto questo avviene dentro un sistema simbolico culturale, quello italiano, che ancora oggi identifica la cura con le donne, avremo quel perfetto connubio di genderizzazione della professione e squalificazione economica. Da questo circolo vizioso sembriamo non saper uscire e infatti oggi nella categoria di lavorator* della cura finiscono tutte quelle soggettività marginalizzate: donne, persone razzializzate, soggetti non binari, persone con diversi orientamenti ecc. Allo stesso tempo nei nostri contesti formativi aumentano i bisogni di cura che osano forzare il sistema ponendo temi quali ad esempio il benessere di student3 e la prevenzione del disagio che colpisce sempre più e forte nei gradi superiori di scuola. Mi sembra che a fronte di queste istanze la risposta avvenga non in termini di un ripensamento del valore e del paradigma della cura ad ogni livello della piramide della docenza, ma si preferisca creare apparati separati e distaccati (penso ai vari “uffici” o “sezioni” o “sportelli” presenti in molte scuole superiori o in Università) affidati a quei soggetti a loro volta marginalizzati dentro al sistema: siano essi insegnanti precari o persino student3 stess3 con funzione di mentoring o tutoring, volontarie e persone proveniente da lavoro sociale. Perché non si ridefinisce invece il ruolo docente? Perché si preferisce esternalizzare il problema e non si predilige un approccio che riporti la cura come parte integrante della relazione educativa tra docenti e discenti anche nei licei e nelle università? Temo che la risposta resti sempre la stessa. E sta nella cultura più che negli ordinamenti e negli stipendi che ne sono una logica.
“Nel decalogo dell’impopolarità femminile prima sta la bellezza. Gianini Belotti insiste in più passaggi del romanzo sulla serafica e innocente beltà di Italia, rendendola una sorta di figura raffaellesca in evidente contrasto con la bruttezza umana che la circonda”. Nonostante esista una consolidata tradizione letteraria su questo tema resta ancora argomento difficile da affrontare, anche in ambienti femministi, e invece a mio parere è una traccia che andrebbe considerata all’interno delle dinamiche di relazione tra donne, condannate più che alla generatività degli incontri a una velata competizione tra loro.
Questa domanda mi spinge a tornare su quella parte del mio saggio di più complessa gestazione. Pur partendo da una base autobiografica molto viva e molto scoperta lo sforzo dal mio canto è stato quello di ricercare un’eco nel confronto con le altre. Ed è accaduto che in molte compagne, amiche e non, colleghe, saltasse fuori l’esistenza di vissuti dolorosi, affaticati, a volte mortificanti, agiti o inflitti per mano di altr3. In posizioni diverse e con gradi di consapevolezza differenti ma nella comune dimenticanza di quel vincolo di reciprocità che sarebbe misura della posizione transfemminista e pratica politica condivisa. Invece, spesso si inciampa e la pietra – o sassolino che sia – hanno nella bellezza un elemento che ritorna. Credo che sia ancora molto lunga la strada da compiere sul tema della critica alla bellezza: sia come costrutto di mercato che contribuisce e rendere le donne innocue sul piano politico e sociale prosciugandone risorse materiali e immateriali, sia come percepito che innesca competizione e acrimonia. Su questo spartito affettivo-emotivo acquisito dentro un’educazione sessuata, radicata nella tradizione, non abbiamo ancora affinato sufficienti dinamiche di disarmo e spesso continuiamo a separarci anziché unirci sulla scia di vissuti che incardinano la nostra educazione sentimentale. Come insegnanti e femministe dovremmo prestare molta attenzione a quanto la nostra biografia possa orientare e improntare di sé la relazione educativa: i nostri atteggiamenti sono condizionati da quella stessa competitività e performatività che passa nella relazione genitoriale e in special modo in quella materna. Su questo Elena Gianini Belotti ha aperto la strada. Penso che sia nostro compito spostare lo sguardo oltre l’infanzia per ritrovare nell’età adulta quanto di tale educazione “implicita” giochi nei nostri rapporti. In questo senso il titolo del volume è rivelativo dell’intento di fondo di tutto il lavoro: ricordarci del nostro sé bambino vuol dire riconoscere i tratti di condizionamento e gli stereotipi ma anche la relazione importantissima con le altre che impronta e condiziona, nel bene e nel male, la costruzione delle nostre soggettività e le possibilità di aprici o meno a un dialogo in sorellanza.
Accanto al tema della bellezza – che da dono è diventato progetto e obiettivo – e della bruttezza – trasformata quindi in colpa, sciatteria, mancata volontà, emarginazione sociale e povertà – affronti anche il tabù della “non giovinezza” che cambia sicuramente il nostro rapporto con il sistema scuola (la veterana non può comportarsi come la neo assunta giovane e irriverente): la libertà, tu scrivi, è anche quella di invecchiare, di concedersi stagioni diverse. In una società dell’eterna giovinezza, scollegata dunque da qualsiasi verità biologica, una docente che difende la propria vecchiaia (e che non gioca la carta della somiglianza e vicinanza con gli studenti e le studentesse) può avere un effetto eversivo e rivoluzionario?
Qui si apre quella parte della mia riflessione necessariamente ipotetica e in divenire. Sono consapevole che la sfida che ho davanti è proprio quella di declinare l’invecchiamento dentro il contesto educativo che rappresenta il mio quotidiano. Nel frangente specifico di quest’epoca che tra narcisismo massmediatico e derive tecnocratiche sta sostituendo alla materialità di un corpo che invecchia l’alias di un corpo sospeso in un’eterna giovinezza, non mi sfugge la grande difficoltà di narrare e legittimare un processo così poco attrattivo come l’invecchiamento. Abbiamo, d’altra parte, aggiunto un’età (la quarta) per procrastinare ancora la possibilità di dirci anziane e tutto questo avviene nella cornice di un Paese che demograficamente invecchia ma gioca all’eterna primavera da Potoshop. Sono ormai convinta che ciò di cui vorrò con sincerità raccontare sarà la mutazione, certo, ma anche la radice corporea del mio sentire e agire. Il corpo senile delle donne è un corpo ribelle da tempo perché si sottrae al male gaze e perché si libera dal dovere riproduttivo. Non a caso le streghe venivano spesso descritte e rappresentate come vecchie discinte. Il binomio scabroso era e resta il sessuale e il senile e, fuori dalle rappresentazioni simbolico culturali, la sessualità dei corpi anziani così come dei corpi non conformi è un enorme e paradossale rimosso. Per questo ho consegnato al finale del libro un’immagine per me tra le più poetiche del romanzo di Gianini Belotti: il grembiule rosso d’Italia Donati. Quel grembiule messo a segnale del suo corpo annegato. Un’effige del desiderio che ho provato a spogliare del connotato sessista tradizionale che assume la parola per riportarla invece alla radice trasformativa, esplorativa, espressiva. La rivoluzione sarà allora portare ciò che il contesto periferizza, occulta, rimuove e farsi ancora e in altro modo pietra d’inciampo, scandalo.

Il valore della memoria, al di là delle retoriche o delle ricorrenze, permette di sentirsi parte di un movimento comune di pensiero e di azione e di uscire fuori dalla logica del cambiamento come prodotto di eccellenze o di individui isolati e straordinari. Inoltre la memoria consente un contatto con una dimensione etica e con una pratica quotidiana in cui abbiamo la possibilità di scegliere. Qual è la tua opinione in merito?
Ho una formazione da filosofa e mi sono dedicata a lungo all’estetica come modello epistemologico alternativo a quello delle scienze esatte. Credo che la memoria abbia una radice poietica che la iscrive più nella dimensione estetica che in quella storica. E se le storiografie sono essenziali al tramandarsi di memorie, il meccanismo che istaura e crea memoria è affine a quello creativo. Molto ci hanno detto le riflessioni delle letterate sull’autobiografia e intellettuali come Cristina Rivera Garza affermano la legittimità di un approccio che guarda al pianeta intero come a un grande archivio che contiene strato su strato le voci di tutt3, viventi e non viventi, umani e non umani. Questa premessa mi permette di affermare che nessuna pedagogia trasformativa può prescindere dalla creazione di memoria: la storia delle donne e delle soggettività marginalizzate è un processo creativo che impegna a diversi livelli e in diverse posizioni chi scrive, chi racconta, chi fa ricerca storiografica, chi trasmette la cultura/le culture e chi educa. Essenzialmente il ruolo dell’insegnante si pone al crocevia di queste azioni perché dovrebbe facilitare l’accesso alle memorie e al contempo promuovere la creazione di nuove costellazioni, di nuove genealogie. La tendenza svalutante che accomuna memoria e insegnamento non è frutto del caso ma dovrebbe leggersi dentro la stessa intenzione che è sostituire al potenziale creativo di memorie plurime e intersezionali, il moloch di una tradizione, di un canone, egemone, semplificato e che assolve gli oppressori. Gianni Rodari affermava che insegniamo la poesia non perché si diventi tutti poeti ma perché nessuno sia più schiavo. Facciamo memoria non perché aspiriamo tutt3 all’immortalità delle nostre stirpi ma perché nessuno sia più escluso e tutt3 possiamo riconoscerci nella comune radice della convivenza. Che si fa così etica e poetica.
A Roberta e Samanta grazie per questa condivisione.


No Comments