
09 Gen La sfida creativa delle città. Intervista a Maurizio Carta
La sfida creativa delle città
Intervista a Maurizio Carta
a cura di Ivana Margarese

Comincerei col chiederti delle “città aumentate”, cosa dobbiamo intendere con questa espressione?
Oggi le città devono saper dare una risposta concreta alle principali quattro rivoluzioni della società contemporanea: vivere nella società della conoscenza, gestire la società delle reti, mitigare e combattere il cambiamento climatico e riattivare il metabolismo urbano. Sono convinto che davanti alle crisi che stiamo attraversando serva un nuovo paradigma che rigeneri la città dal punto di vista dei suoi spazi di vita, sociali, culturali e produttivi, per fornire nuove risposte improrogabili. Nel 2017 ho definito questo nuovo paradigma urbano “città aumentata” (Augmented City), una città in grado di amplificare risorse, capacità, opportunità e risposte delle comunità a partire dalle condizioni e dagli abitanti reali, senza consolatorie fughe iper-tecnologiche verso gli pseudo-paradisi delle smart cities. La città aumentata non è una illusione, ma è ancora una città come la conosciamo che, però, adotta un sistema coerente di politiche, processi, strutture architettoniche e urbane, decisioni regolative e norme per accrescere la qualità dell’insediamento umano attraverso l’azione congiunta di dispositivi cognitivi senzienti, collaborativi e intelligenti, attraverso l’incremento della produttività, della creatività e del riciclo, aumentando la resilienza, la fluidità e la reticolarità.
La città aumentata, soprattutto, si evolve attraverso strategie incrementali e adattive che in maniera creativa stimolino o adottino le innovazioni urbane, rifiutando un approccio puramente regolativo ed esclusivamente dall’alto. La città aumentata vive del fertile tumulto della sua comunità.
Per noi urbanisti, significa tornare ad agire sui cicli di vita identitari e a lavorare sulle componenti vitali del metabolismo urbano attraverso un bricolage fertile che, come in una barriera corallina, generi nuova vita da materie prime dismesse da altri cicli vitali in una straordinaria e potente creatività urbana e umana.
Sottolinei spesso che bisogna imparare dalla natura soluzioni creative per vivere meglio.
La città è un artefatto complesso e affascinante, perché essa non è mai il prodotto di una unica volontà deterministica che produce azioni singole, ma è il risultato dell’emergere di innovazioni improvvise, di dinamiche indipendenti all’inizio ma poi interrelate dalla creatività degli abitanti, di azioni messe in moto da un numero molto grande di attori individuali e collettivi, ciascuno dei quali nel perseguire i propri fini si ritrova ad adattarli entro un sistema di interrelazioni reciproche, il cui esito supera sempre le intenzioni e il controllo degli attori più potenti. La città è un artificio speciale poiché imita la natura nella sua exaptation, la scintilla creativa dell’evoluzione. Il concetto è stato consolidato nel 1982 da Stephen J. Gould ed Elisabeth S. Vrba per definire il “termine mancante” nella teoria dell’evoluzione di Charles Darwin, in grado di descrivere il processo con cui la natura si evolve per innovazioni casuali e potenzialmente ridondanti in modo da permettere che un organismo possa cooptare funzionalmente un tratto – anche un errore genetico – sviluppatosi per altre ragioni adattive, in uno straordinario bricolage creativo. Trasferire il termine alla città significa esaltare la sua capacità creativa di evolversi non solo per adattamenti e risposte prevedibili, ma anche per variazioni improvvise, casuali, ridondanti e talvolta generate dal basso, che vengono utilizzate dalle comunità attraverso una “cooptazione funzionale” per assegnarvi nuove funzioni che poi si consolideranno per adattamento creativo dando forma a nuovi modi di abitare la città, a diverse modalità di produzione, a cambiamenti nella mobilità, a innovazioni culturali.
La domanda a cui dobbiamo rispondere è: come riattivare la capacità creativa, generativa e innovativa della città in piena era dell’Antropocene? Alla fine del secolo scorso Eugene Stoermer e Paul J. Crutzen hanno introdotto per la prima volta il termine “Antropocene” per indicare le conseguenze sul pianeta della Rivoluzione Industriale attraverso l’accelerazione delle modifiche territoriali, sociali, economiche e climatiche prodotte dall’uomo fin dall’inizio della lunga marcia dell’homo sapiens cinquantamila anni fa dall’Africa, attraversando continenti, soggiogando o annientando altri ominidi, erodendo risorse naturali, piegando il pianeta alla sua presunta intelligenza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale un ancor più pervasivo e accelerato “antroposviluppo” ha prodotto effetti anabolizzanti tali da rendere immensa l’impronta umana sul pianeta, ben oltre qualsiasi altro effetto dominante, relegando a specie da sottomettere tutte le altre. Insieme al suolo sono state consumate con voracità le trame vegetali rurali e silvestri e le strutture identitarie dei palinsesti culturali, sono stati anestetizzati metabolismi vitali, interrotti i cicli delle acque e dei rifiuti e sclerotizzati quelli della mobilità, rendendoli inefficaci. Gli habitat umani hanno tradito il patto fondativo con la natura e hanno invaso gli ecosistemi naturali, anche risvegliando ed espandendo malattie prima confinate e separate.

Quali sono gli indici rilevanti di benessere per una città?
Misurare il benessere di una città è importante poiché esso è lo specchio della qualità della vita e della felicità dei suoi abitanti: la città stessa nasce con questa missione di sicurezza e benessere rispetto ad altre forme di insediamento. Esistono numerosi modi per misurare questo benessere e ogni anno le classifiche sulla qualità della vita infiammano il dibattito pubblico, accontentandosi di esprimere un giudizio invece che suggerisce un “indizio” su cosa fare e verso dove andare. Voglio io proporre alcuni indici/indizi utili a stimolare il benessere della città.
Il primo indice è la capacità di una città di essere più senziente per percepire in tempo reale i problemi degli abitanti e dell’ambiente e fornire risposte tempestive. Significa incrementare l’uso di nuove fonti di dati, parametri e strumenti cognitivi, valutativi e attuativi per un’urbanistica sempre più basata sulla conoscenza istantanea e distribuita e capace di produrre soluzioni tempestive, efficaci, solide e orientate ad uno scenario di cooperazione. Il secondo indice è relativo alla sua capacità di essere aperta e collaborativa attraverso l’attivazione dell’alleanza tra la dimensione civica e quella tecnologica per agire efficacemente nella società della condivisione in cui viviamo e per far atterrare questa collaborazione in nuove forme, condivise e porose, dello spazio collettivo. Il terzo indice riguarda l’intelligenza, cioè la capacità di una città di dotarsi di un nuovo “sistema operativo” che metta a sistema le diverse esigenze della comunità (elaborazione delle politiche, regolamentazione, fiscalità, servizi per la famiglia, mobilità, manutenzione degli edifici, qualità ambientale, innovazione, alloggio, gestione urbana, pianificazione dello spazio).
Le città devono tornare produttive – il quarto indizio – incentivando la rilocalizzazione delle imprese, delle manifatture tradizionali e innovative, dei makers e dei nuovi artigiani digitali all’interno di distretti urbani creativi/produttivi per stimolare, agevolare e localizzare adeguatamente il ritorno della produzione nelle città, per la ricostituzione di una sua indispensabile base economica. A questo si deve aggiungere la creatività in termini di ecosistema, integrando la cultura, la comunicazione e la cooperazione (risorse primarie della creatività urbana) per facilitare la costituzione e gestione di distretti culturali e creativi attorno alle iniziative di maggiore vitalità, e per aumentare la reputazione, amplificare l’impatto e consolidare l’eredità delle attività culturali.
Anche il tasso di riciclo urbano è un indice importante, per rimettere in circolo la dismissione, prendendo una funzione da un contesto e immettendola in un altro per riattivarne il metabolismo, o allocando funzioni plurime che fungano da innesco della rigenerazione del dismesso. Viene così aumentata la resilienza, altro fondamentale indice, affrontando la sfida della transizione ecologica verso lo sviluppo decarbonizzato (certificati verdi, eco-bonus, incentivi per il consumo zero di suolo, etc.).
Infine, il benessere delle città si deve misurare sulla loro propensione ad un policentrismo che aumenti la qualità della vita di prossimità dei diversi quartieri e ne potenzi i servizi (eliminando quella iniqua monocentralità che determina una drammatica periferizzazione del resto), ma che, al contempo, sfugga alla segregazione stimolando flussi differenziati di abitanti che animano le diverse parti, garantendo la necessaria miscela di funzioni e persone come antidoto alla ghettizzazione.
Bricolage, arcipelago sono due metafore che utilizzi per descrivere la città del futuro. Mi interesserebbe sapere se ci sono città che puoi raccontarci come rappresentative di questa maniera di abitare.
Credo in maniera convinta in un’urbanistica aperta e collaborativa, un’urbanistica aperta al dubbio fecondo, la quale, anziché farsi portavoce del potere, diventi bricolage e utilizzi, ricomponendoli, i materiali che gli provengono dalla percezione condivisa della realtà. L’urbanistica perde il mito della sua razionalità astratta e il suo carattere progettuale assoluto e si qualifica come attività ermeneutica di una comunità reale. L’opposizione tra urbanista-scienziato e urbanista-bricoleur è stata efficacemente descritta da Claude Lévi-Strauss nel libro Il pensiero selvaggio: il primo ragiona a partire da un problema che merita una soluzione senza vincoli a priori e attingendo a strumenti predefiniti, mentre il secondo è condizionato dagli elementi con cui si confronta, utilizza il sapere profondo costruito nella pratica del fare, scompone e ricompone certezze per adattarle alle esigenze della realtà. L’urbanista-bricoleur, quindi, innova procedendo per improvvisi cambi di direzione e punti di vista, attraverso una capacità di ricombinare costantemente gli esiti dell’esercizio del dubbio.
L’urbanistica-bricolage è utile per riconoscere che in Italia non esistono solo le quattordici città metropolitane, ma dobbiamo facilitare – montando materiali diversi – lo sviluppo degli “arcipelaghi territoriali” come sistemi insediativi altrettanto preziosi perché sono oggi in grado di offrirsi come luoghi di vita, di produzione, di educazione, di fruizione culturale alternativi all’aggregazione metropolitana e alle relative congestione, diseguaglianza e, abbiamo visto, insalubrità. L’arcipelago territoriale è un sistema di insediamenti urbano/rurali collegati dalle trame produttive tradizionali e dalle infrastrutture di paesaggio, il cui sistema connettivo è spesso composto dai reticoli ecologici verdi e blu.
Da anni in Europa e negli Stati Uniti alcuni sistemi urbani stanno mettendo in discussione la metropoli, sperimentando strategie di sviluppo delle città intermedie che utilizzano l’approccio del bricolage e la visione dell’arcipelago per contrastare la crisi delle grandi città. Tra gli esperimenti voglio selezionare due città apparentemente lontanissime e diverse, ma che invece sono accomunate da una visione comune, tanto da essersi oggi gemellate: Detroit, in Usa, e Favara, in Sicilia.
Tra le numerose sperimentazioni in corso, infatti, Detroit è quella più avanzata, il prototipo della città che crolla e rinasce dalle sue ceneri. Dopo essere stata la capitale dell’industria automobilistica, negli anni Trenta era la città con il più alto tasso di crescita al mondo, a partire dalla fine degli anni Ottanta inizia un inesorabile declino, diventando l’emblema delle città in contrazione. Teatri sontuosi come il Michigan Theatre, che gareggiavano nel mondo della lirica, abbandonati e trasformati in parcheggi per garantirne la manutenzione (come si vede in una delle scene dello splendido film Only Lovers Left Alive di Jim Jarmush del 2013 ambientato in una lugubre Detroit), il patrimonio artistico dei musei in vendita per pagare i debiti, case costruite con vorace fame di alloggi e disabitate da inquilini che fuggono lasciando ancora il caffè a bollire per sottrarsi all’ufficiale giudiziario che pretende il pagamento di un affitto impossibile da pagare, e poi scuole senza più alunni che diventano rifugi per le gang e migliaia di officine, negozi e chiese abbandonate come se la città fosse stata attraversata da un tornado. Una lenta agonia che sembrava non arrestarsi, fino a quando la stessa comunità non comprende il poderoso valore creativo del bricolage di quella straordinaria qualità di patrimonio urbano in disuso o in abbandono, capace di rinascere dopo la sua obsolescenza per trasformarsi in un arcipelago di atelier, mercati, laboratori creativi, boschi, frutteti, fattorie urbane, stagni e laghi artificiali, ridisegnando completamente la fisionomia della città. Detroit ci insegna che progettare una città che ricicla i suoi spazi in obsolescenza significa soprattutto abbandonare la tradizionale logica lineare espansiva per adottare un nuovo modello di città intelligente e creativa, sensibile al contesto e resiliente al cambiamento, che ridisegni il modo con cui ci muoviamo, che ritessi rapporti creativi con l’ambiente e il paesaggio e che alimenti nuove culture insediative urbane, in grado di riattivare gli organi vitali della città e i suoi cicli di vita, ma anche di reagire tempestivamente agli scenari di declino.
Cambiando scala, ma non visione, quella di Farm Cultural Park a Favara non è la solita storia di una periferia urbana delle città moderne in cui emergono i semi della rigenerazione urbana, ma è la storia decennale di un centro culturale indipendente che è diventato un nuovo paradigma urbano. In dieci anni ai Sette Cortili, grazie alla visione di Andrea Bartoli e Florinda Saieva e di numerosi compagni di avventura (anche io tra questi) il programma evolutivo non si è mai fermato, perché Farm è un organismo vivo e vitale che si trasforma e si espande in continuazione, arricchito ogni giorno dall’energia delle centinaia di migliaia di persone che lo attraversano, che vi sostano, che vi collaborano, che lo visitano: tribù nomadi della cultura, della creatività e dell’innovazione che raggiungono il tempio della loro ricerca emozionale di un altro modo di essere città. Oggi Farm è uno straordinario arcipelago culturale composto dalle numerose iniziative e imprese che sono nate attorno ad essa o come suo spin-off in tutta la Sicilia e l’Italia. Per me Farm è un “acceleratore di particelle culturali” che, attraverso l’enorme energia prodotta dallo scontro di materia culturale, sociale, tecnologica, artistica e politica, ci permette di vedere nel futuro delle politiche di rigenerazione urbana dal basso basate sulla cultura, sulla condivisione e sull’innovazione sociale. Oggi per Farm è venuto il momento di uscire dalla sua comfort zone, di superare la fase nascente dell’innovazione per assumersi la responsabilità politica e culturale di diventare una piattaforma del cambiamento, per scrivere una nuova storia dell’innovazione culturale, sociale e urbana, concorrendo a scrivere nuovi protocolli e regole perché “cento Farm fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino” per estendere il loro diverso presente ad un futuro collettivo a prova di ogni restaurazione.

Le crisi, le scosse, sono possibilità di nuovi inizi, sproni per ripensare in maniera diversa ciò che si era dato per stabilito. Questo orizzonte immaginativo è necessario al pensiero e all’educazione. Vorrei chiederti una breve riflessione in merito.
Le sfide della metamorfosi in una vera società della conoscenza, della circolarità e dell’innovazione ci impongono la responsabilità di re-immaginare le istituzioni educative e le loro relazioni con il territorio per formare persone in grado di agire nel nuovo e sempre più dinamico scenario, in cui metodi e strumenti canonici rischiano di essere obsoleti. Nel nuovo orizzonte la nuova missione delle scuole e delle università è quella di essere un motore culturale e sociale per alimentare costantemente la domanda di educazione della persona e di formazione delle persone, di collaborazione interdisciplinare e di crescita culturale della comunità locale. Una educazione che torni a nutrire la libertà di pensiero e di parola, l’autonomia del giudizio e la forza dell’immaginazione e che non agisca solo alla ricerca spasmodica di un profitto materiale. È quella scuola “organo di rango costituzionale” che predicava Piero Calamandrei, convinto che essa dovesse formare i cittadini per la democrazia appena conquistata. Dobbiamo costruire quella “utopia dell’educazione” di cui parla Marc Augé nel sul libro sul futuro: «l’unica speranza di riorientare la storia dell’uomo nella direzione dei fini».
Significa, anche, reimmaginare il rapporto docente-studente, perché non è il figlio-Edipo quello che deve emergere, che per conquistare autonomia e potere si lancia nella guerra contro il padre. Né è il figlio-Narciso che resta immobile prigioniero della propria immagine giovane e del colore del tempo in un selfie perenne e autogratificante. Ma è il figlio-Telemaco – come dice Massimo Recalcati – di cui abbiamo bisogno come padri/docenti: dello studente che cresce, matura e si rafforza in un patto pedagogico con il docente, il quale richiede, tuttavia, che i padri non siano Kronos, avidi divoratori di futuro dei loro figli, ma che abbiano la generosità di Prometeo e la sua voglia di condivisione che altro non è che una tensione per una pedagogia integrale.
Essere Telemaco/studente non è facile, serve la forza per resistere alle insidie del dubbio e soprattutto la fiducia in Ulisse. Essere Ulisse/docente non è facile, perché impone la responsabilità di non tradire attesa e fiducia dei giovani. Anche questo deve essere una educazione che riattivi il futuro, che alimenti la fiducia e la speranza.
La scuola e l’università che mi piacciono sono l’esempio perfetto di quella che Heinz Von Foerster, eminente scienziato austriaco, chiamava la “macchina non-banale”, un meccanismo che si comporta in modo diverso dal prevedibile perché la relazione input-output non è stabile né prevedibile. E lo studente quando entra nel sistema educativo è proprio una perfetta macchina non-banale, imprevedibile e curiosa: posta una domanda fornirà una risposta non esatta, non prevedibile, ma ricca di creatività e innovazione. E il nostro compito è, mentre lo formiamo a rendere più esatta la sua risposta, quello di conservare la forza della sua non-banalità, senza comprimere creatività e capacità di elaborazione del pensiero, perché la vita ha bisogno certamente di risposte corrette, ma anche non banali, non relegate ad una arida relazione univoca input-output. Ricordiamo tutti la memorabile scena de L’attimo fuggente di Peter Weir in cui il Prof. Keating fa leggere agli studenti l’arido trattato sulla poesia ridotta al calcolo di un’area su un diagramma cartesiano. E la sua reazione è: «escrementi!… non stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia» e gli fa strappare le pagine di quel libro che avrebbe ridotto creatività, empatia ed emozione degli studenti.
Per garantire questa creatività occorre recuperare le dimensioni elevate della complessità educativa: l’empatia, il pensiero critico, la visione sistemica dei fenomeni, l’educazione alla comunicazione, l’immaginario e la creatività. Significa ripensare lo spazio relazionale e comunicativo dentro le scuole e le università.
“Parlare di futuro, soprattutto in un paese come l’Italia che lo ha cancellato non solo dalla produzione istituzionale (siamo forse l’unico paese europeo che non si è dotato di un documento di visione e strategie di medio-lungo termine) e dal dibattito pubblico, ma anche dalle discussioni da bar, dai temi della maturità, dai post sui social network, significa proprio rompere un sistema fatalista che si accontenta di manutentare il presente sperando che il futuro – ma è ancora il buon vecchio fato – arrivi a salvarci”. Trovo questa tua considerazione particolarmente importante dal momento che il pensiero necessita come si diceva di un orizzonte utopico, in cui bisogna immaginare avanzando da ciò che è verso ciò che dovrebbe essere, di uno sguardo verso l’avvenire in un progetto di rinnovamento del reale conosciuto attraverso schemi canonici e consolidati.
Gottfried Wilhelm Leibniz sosteneva che “il presente è saturo del passato e gravido dell’avvenire”. Questo per me significa sentire la responsabilità del diverso presente – il presente che modifichiamo con la nostra azione quotidiana – nell’avere cura della gravidanza dell’avvenire e di allevare con amore il futuro che abbiamo generato.
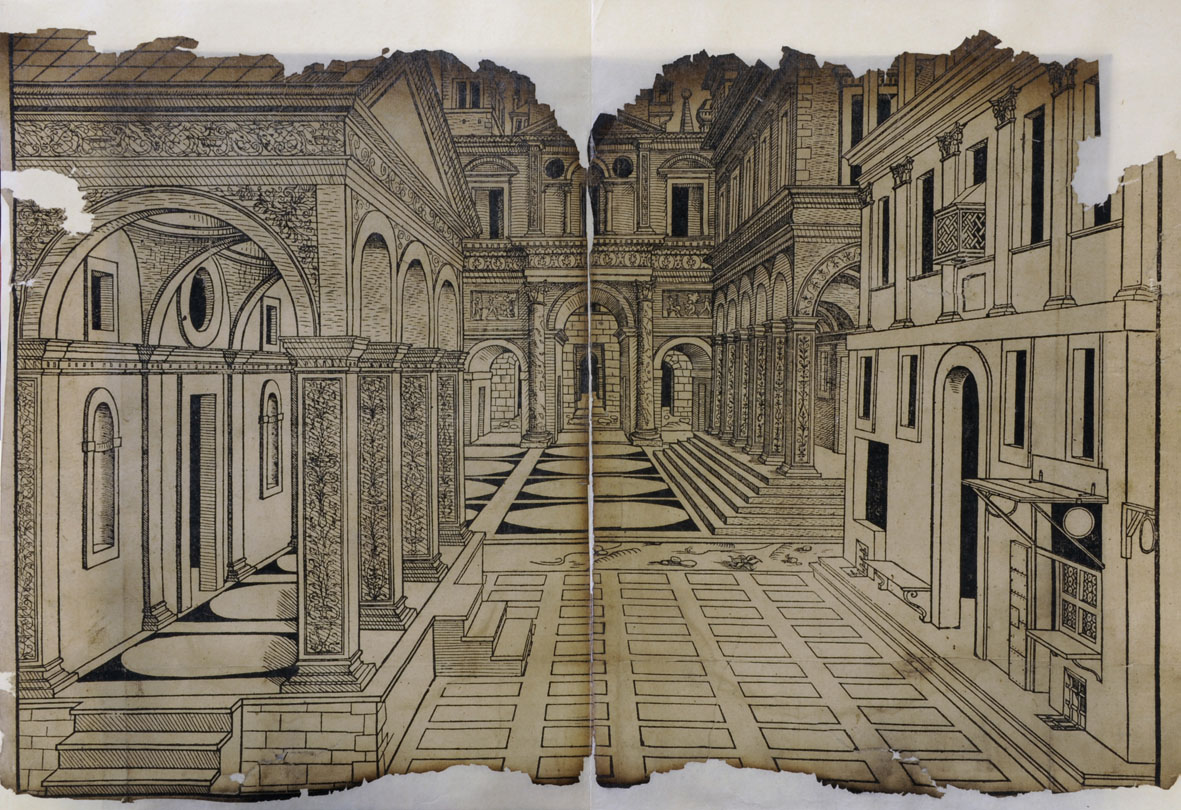
Biografia

No Comments