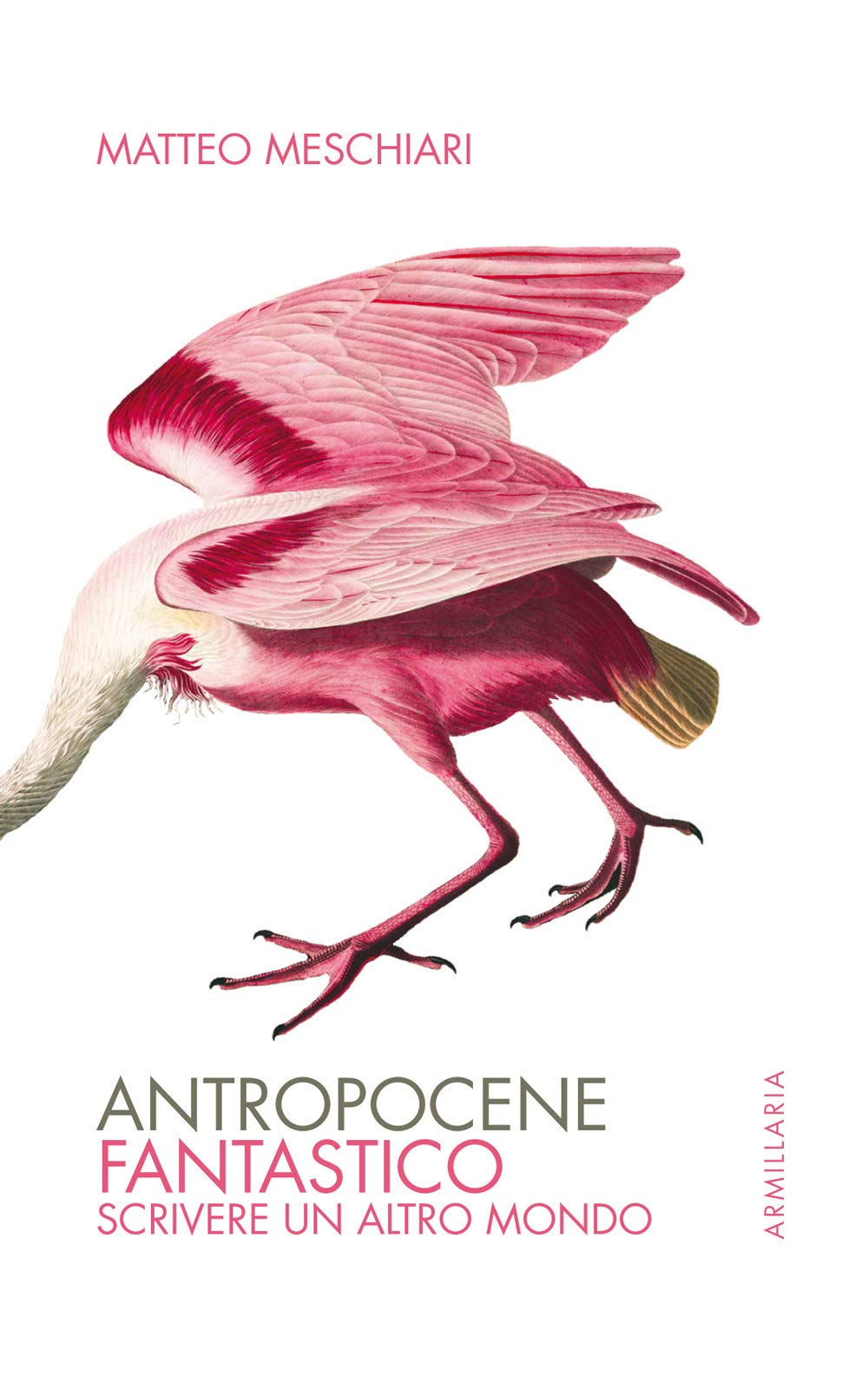
26 Ott Antropocene Fantastico. Scrivere un altro mondo
Antropocene Fantastico. Scrivere un altro mondo
Dialogo con Matteo Meschiari
di Noemi De Lisi
Immagini fotografiche di Jitka Hanzlová

Antropocene Fantastico. Scrivere un altro mondo (Armillaria, 2020) è un phamplet di Matteo Meschiari che riordina e approfondisce il discorso iniziato sul ruolo della narrazione e del narratore ai tempi dell’Antropocene. Il carattere del testo è duplice. Da una parte non si discosta dal phamplet classico, e infatti ne sfrutta i toni polemici nei confronti di certi modelli immutati e immutabili di un’idea di letteratura italiana “un’idea fragile, inadeguata, fatta di nomi, di voci, di genealogie locali e di microtradizioni editoriali” (p. 17). Dall’altra parte si propone come un vero e proprio manuale di narrazione, o meglio, di immaginazione. Meschiari sembra parlare alle nuove generazioni di narratori emergenti, indica loro le basi sulle quali costruire la figura del vero scrittore dell’Antropocene fornendo libri e tematiche-chiave da affrontare, generi letterari da privilegiare e consigli concreti su come sopravvivere al collasso del sistema-Terra attraverso la scrittura.

Grazie, Matteo, per aver accettato questa intervista. Partiamo subito con l’approfondire le radici di Antropocene Fantastico. Non desidero sapere l’iter del testo. La tua ricerca e il lavoro di divulgazione circa una presa di coscienza collettiva sull’antropocene sono abbastanza note grazie alle tue pubblicazioni precedenti, ai progetti in cantiere e agli articoli sui siti La Grande Estinzione e Il problema di Grendel (https://ilproblemadigrendel.net/). Invece, vorrei addentrarmi subito nelle “aree di soglia” (p. 45) fra il pubblico e il privato di un’opera, e domandarti perché hai deciso di pubblicare questo phamplet. In Antropocene Fantastico, affermi: “Quello che manca invece è una discussione coraggiosa sui contenuti. Sul cosa prima che sul come. Sul perché prima che sul chi.” (p. 17) Per questo mi azzardo ad andare oltre Matteo Meschiari, lo scrittore, il lettore, e domandare una motivazione; qualcosa sulla quale non ci si sofferma più, dato che il perché ormai lo chiedono solo i bambini.
La motivazione profonda di Antropocene fantastico è che io per primo non mi rendo conto che siamo davvero entrati in una nuova era oscura, e che pensare solo l’oscurità evoca immancabilmente l’abisso. Letteralmente sono spaventato, ma non abbastanza, non come dovrei. La paura fa commettere errori, è una scorciatoia cognitiva, ma è anche una spinta evolutiva, prepara a una reazione. Prima o poi la paura del collasso arriverà per tutti, anche per chi si ostina a negare, ma quale sarà la reazione? Ci rassegneremo alla tirannide di un falso messia? Seguiremo la pancia verso il disordine? Ci rintaneremo in cantina? Nel migliore dei mondi possibili reagiremo in tempo, troveremo una soluzione, salveremo tutti. Da cosa però? Il problema è guardare nel posto giusto. Il collasso che immaginiamo è sempre istantaneo, apocalittico, globale. Invece può assomigliare all’incendio di una casa in periferia: la gente per lo più si salva, vivrà un trauma per gli anni a venire, ma è viva. Invece libri, ricordi, fotografie, oggetti cari sono perduti, ridotti in cenere. Più passa il tempo e più ci rendiamo conto però che proprio queste cose erano la nostra vita, erano parti di noi, ed essere sopravvissuti, ma con porzioni amputate, alla lunga può somigliare alla morte. Quindi no, non mi sto preparando all’apocalisse zombie, semplicemente vedo che molte cose stanno bruciando adesso, cose che siamo noi, che ci aiutano a essere donne e uomini, e non ho voglia di pensare per quello che mi resta da vivere e per i miei figli un futuro da sopravvissuti emotivi, culturali, cognitivi. Antropocene fantastico è il ramo piccolo di un albero di salvataggio. Una reazione pessimistica al pessimismo.
Il tuo testo è molto concreto. Nel senso che fornisce un arsenale di strumenti reali, alla portata di tutti, per sopravvivere al collasso del sistema e a quello cognitivo conseguente l’Antropocene. Lo strumento primario (chiamarlo strumento sembra paradossale laddove se ne parla come bisogno istintivo inscritto tra la fame e la sete) per la salvezza dalla distruzione è l’immaginazione, e di conseguenza, la scrittura fantastica. Parli di creare (scrivere) mondi non alternativi allo status quo, non fantastici intesi come “fuga dalla realtà”, ma di interi sistemi cosmici immaginari per rafforzare la realtà, comprenderla meglio, sopportarla e continuare a viverla. Tali mondi fantastici, comunque, non si devono rappresentare come delle utopie, altrimenti sarebbero solo una maschera. Invece, consigli di popolare i mondi immaginari per sopravvivere anche di mostri, di animali estinti: “Se ‘scrivete mostri’, invece, siete già nella Resistenza.” (p. 63). Ma cosa intendi esattamente con “Resistenza”? Chi c’è dall’altra parte, chi minaccia la sopravvivenza dell’immaginazione: l’Antropocene oppure il panorama dell’editoria italiana?
Homo sapiens sapiens. Noi, con tutto ciò che facciamo e non facciamo. Il problema secondo me è che il sistema neoliberista in cui siamo immersi da almeno quarant’anni scoraggia sistematicamente il libero immaginario, e siamo insomma allevati dalla culla alla bara per vedere solo alcune cose e mai altre, come i cani da tartufo. Resistere significa sottrarsi ai bias cognitivi che tutti abbiamo e che alcuni caporali spregiudicati usano contro di noi. Significa rendersi conto che il nostro miracoloso cervello è anche una trappola fifona e rassicurante che quando il leopardo ci ha già azzannato ci fa dire “andrà tutto bene”. Resistenza è immaginare l’improbabile, l’impossibile, l’inverosimile, perché è lì che lampeggiano sempre le intuizioni di salvezza. Quello che ho capito in una trentina d’anni di studio è quasi banale: la parola poetica può cambiare la vita. Perché, allora, non usare le parole per vedere quello che sta succedendo attorno a noi, al di là di mode, interessi economici, conventicole? Una certa editoria italiana, cioè alcuni editori, alcuni scrittori, alcuni “professionisti”, sono la mosca sul sedere dell’elefante-Antropocene. Come una mosca sono attaccati senza saperlo alla superficie di qualcosa di immenso, sono insomma troppo vicini per vederlo davvero, e allora tagliano corto, dicono che non esiste. Negazione, scherno, ostilità sono le reazioni immediate, ma i più fastidiosi sono proprio gli scrittori che si appropriano di parole-chiave (Antropocene, collasso, distopia, animalità, animismo, sopravvivenza…) e le bruciano per superficialità e opportunismo. Creano insomma un rumore di fondo che rende tutto più difficile, più confuso, tolgono credibilità a un discorso urgente. E sarebbe facile ignorarli, ma le mosche sono mosche. Per fortuna sono poche. Invece buona parte dell’editoria italiana si sta svegliando e molto presto noterà la differenza tra chi c’è e chi ci fa, tra chi studia e chi copia, tra cruciale e irrisorio.

Per sopravvivere allo status quo, in cui la distruzione del sistema-Terra è odierna e non è proiettata in scenari futuristici, e di cui la Pandemia pare essere solo una piccola ombra, ognuno può scrivere i propri microcosmi. In Antropocene Fantastico si rimarca il concetto di una scrittura innata, che non ha bisogno di particolari paladini, talenti, o scuole, “Scrivere è come accarezzare un siamese, non devi leggerti Il comportamento dei gatti di Paul Leyhausen per farlo” (p. 49). Un’idea di scrittura bel lontana da “Il meccanismo elitario, classista e gerarchico del mondo letterario italiano (…) che ti insegna a leggere e scrivere, la programmazione verso il Premio finale, cioè lo Strega o il successo economico o il posto fisso nel mondo del libro.” (p. 61). Lo scrittore ideale dell’Antropocene, quindi, è un non-scrittore, si tratta più che altro di uno scrittore-collettivo. Lo scrittore dell’Antropocene è chiunque, è l’uomo che si sveglia, mangia, beve, immagina, sopravvive. In questo senso, parli della scrittura come una funzione antropologica piuttosto che sociale. Ma che differenza c’è tra una scrittura collettiva (antropologica) e una scrittura sociale? Entrambe non hanno forse un comune obiettivo?
Se l’obbiettivo è trovare una via d’uscita, una pista di salvezza collettiva allora sì. Ma a me sembra che ci sia ancora chi porta avanti un’idea di letteratura molto settoriale, per quanto dominante, un’idea nata forse nel Settecento, per alcuni addirittura solo nel Novecento, e che in realtà è solo la buccia esterna della cipolla a fronte di migliaia di anni in cui raccontare e sopravvivere erano trefoli della stessa corda. Se la socialità della letteratura ruota attorno alle pubblicazioni, alle vendite, alle cartelle stampa, ai post boriosi e autocelebrativi sui social, ai pettegolezzi, beh sì, anche quella è una piccola società, è un “mundillo”, ma personalmente attira la mia attenzione solo nel momento in cui rallenta o prova a screditare chi lavora sodo. Per conto mio cerco piuttosto di sintonizzarmi con un altrove antropologico, un altrove nel tempo e nello spazio in cui la parola, anche se affidata a professionisti del dire, aveva un compito cosmologico non borghese, sapienziale non egotista, ecologico non economico. Di fronte a uno sciamano, un aedo, un bardo, uno scaldo, lo scrittore contemporaneo troppo immerso nella “società del libro” rischia di somigliare a un prestatore di servizi occasionali. Chi campa o sbarca a malapena il lunario sul disagio degli aspiranti scrittori, chi in modo non limpido si compra la bistecca quotidiana approfittando del narcisismo o dell’ambizione di chi scrive, vive davvero molto lontano dal mondo che immagino. Come tutti dovrebbero praticare fin da piccoli il disegno, la danza, la recitazione senza necessariamente apparire, guadagnare, vincere, così credo che bisognerebbe incentivare le persone, tutte le persone, a scrivere, perché la parola, la frase, come diceva Bachelard, è una potenza primaria dell’immaginazione.

La pubblicazione di un libro è un atto egocentrico, collettivo o sociale? Quali altri mezzi per la diffusione e l’incontro fra le scritture fantastiche per la sopravvivenza esistono oltre alla classica macchina editoriale italiana che “si fonda in gran parte sul sentimento di fragilità (…) un sistema opportunista fondato sul consumismo compulsivo, non diverso da chi vende psicofarmaci invece di restituire alle persone una vita degna di essere vissuta” (p. 92)? I social potrebbero rivelarsi utili in questo senso?
Ci sto pensando. In parte ho già provato a rispondere a questa domanda, che continuo a farmi ogni giorno, con due progetti che ho concepito e curato con Antonio Vena: TINA e DRAUMAR, due esperimenti di scrittura collettiva, il primo sul collasso, il secondo sul sognare durante la pandemia, che però verranno affidati (il primo lo è già) a un’editoria di tipo tradizionale, editoria per fortuna non sempre macchina, non sempre opportunista, non sempre mafiosa e povera di idee. Ma il problema resta: come ripensare il libro nell’Antropocene? Come scardinare l’oggetto-libro dalle deformazioni del mercato? Come emanciparsi dal circolo vizioso editore-distributore? Come fare esoeditoria? Esistono molti esempi che diremmo di “piccoli” e “piccolissimi” editori che lo stanno già facendo, che hanno già preferito sostituire il do ut des mercantile con l’antropologia del dono, che offrono un’alternativa materiale, oltre che culturale, alla mercificazione del libro. Penso ad esempio a Edizioni Volatili di Macerata. Ma se torniamo all’elefante-Antropocene il problema è un altro: come sarà il libro tra 50 anni? A che cosa servirà? Che cosa ci sarà dentro? Per questo, a novembre, con alcune teste lucide e generose, inaugureremo un nuovo progetto, HIEMARIUM, che risponderà collettivamente al “come” e al “cosa” del libro nell’età senza inverno.
Tracciando, o meglio, immaginando l’identikit del tuo scrittore ideale dell’Antropocene, parli di fattori necessari per scrivere l’oggi lontani da qualsiasi danza sonnambula: animismo, vicarianza e sogno. Vorrei soffermarmi su quest’ultimo. Seamus Heaney, durante un’intervista, affermò che un possibile tipo di scrittore era lo scrittore incantatore come Orfeo. Tuttavia, aggiungeva che il canto ipnotico oggi non basta. Lo scrittore non deve incantare il lettore ma indicargli la “desolazione della realtà” come la chiama Yeats. Cosa aggiungeresti alle affermazioni di Heaney? Credi che il canto della poesia possa aiutare a creare mondi fantastici più vasti e profondi rispetto alla prosa? Lo scrittore dell’Antropocene potrebbe dirsi soprattutto un poeta?
Vorrei dire che l’Antropocene ha molto bisogno dei poeti, proprio per quello che diceva Heaney. Ho postato quella frase su Orfeo pochi giorni fa, una frase che viene da un’intervista poco nota, per ricordare appunto questo: non possiamo addormentarci nel canto ipnotico dell’io, dobbiamo aprire gli occhi sulla desolazione del cosmo che abbiamo allestito in appena due secoli di saccheggio ambientale. Heaney non solo ci ha dato una direzione netta, ma ci ha fornito strumenti importanti. Il suo far lievitare il mito celtico e germanico nel quotidiano rurale d’Irlanda è un paradigma sempre traducibile. Scavare nella torbiera della memoria per cogliere il tempo grande di una bacca o del gesto della mano. Riconoscere la mitopoiesi potenziale del presente. Accorgerci che alla fine una cosmologia e una cosmopolitica vanno fondate ex novo. Riavviare qui e adesso quella che Giorgiomaria Cornelio chiama la “salatura delle immagini”, un nuovo Bilderatlas ai tempi dell’Antropocene. Non è questione di prosa o poesia, secondo me, ma di fioritura dell’immaginario.

Antropocene Fantastico non solo mette a fuoco il tipo di scrittore ideale necessario per raccontare la nostra realtà fatta di zone al limite, soglie e distruzione attraverso il genere fantastico, ma definisce anche il romanzo sull’Antropocene ideale. Come ti ho detto all’inizio, scrivi di mondi fantastici, irreali ma il tuo discorso si basa sulla concretezza. E infatti, non ti sei limitato a suggerire un nuovo tipo di romanzo, l’hai realizzato. Storie della grande estinzione (Aguaplano editore, 2020) in uscita il 27 ottobre è il primo esempio di romanzo dell’Antropocene, curato da te e da Antronio Vena. Si tratta di un progetto antropologico-letterario e non poteva che essere frutto di una scrittura collettiva. L’autore di Storie della grande estinzione, infatti, è autore collettivo sotto il nome di TINA (There Is No Alternative), che raccoglie oltre cento scrittori e artisti autori di micro-romanzi e illustrazioni sui mondi fantastici per la sopravvivenza. Cosa ti aspetti dopo l’uscita del libro? Fai una previsione, immagina un mondo fantastico in cui il libro è già uscito da 10 anni.
Tra 10 anni avrò 62 anni e non è assolutamente certo che sarò lì a vedere che cosa accadrà al mondo o ai libri. TINA è un progetto unico, non tanto per la dimensione corale, ci sono altri esempi, ma per il fatto di restare in bilico tra racconto e Theory fiction, tra grande mostra collettiva dell’immaginario e manuale di sopravvivenza narratologica. Nato in modo spontaneo, accettando tutte e tutti, senza verticismi, con un intervento molto professionale ma senza interferenze creative da parte dell’editore, in una collaborazione di talenti diversi e di esperienze lontane tra loro, Storie della grande estinzione è una testimonianza potenziale ma soprattutto è uno strumento concreto: mentre racconta spiega, mentre immagina pensa. In questo senso credo che continuerà a venire capito al di là del grande entusiasmo di chi lo ha scritto e illustrato. Credo che in tempi leggermente più bui di adesso verrà sfogliato come il primo tentativo confuso, fumoso, ma profondamente onesto, di dare a chi verrà dopo delle dritte per non smettere di immaginare, per non immaginare solo l’oscurità.


No Comments